La fortuna di Plinio dalla tarda antichità all’epoca moderna
Eliana Carrara (Università di Genova)
Nicoletta Marcelli (Università di Urbino “Carlo Bo”)
DOI: https://doi.org/10.48241/CARRARA-MARCELLI2020
Pubblicazione: Luglio 2020
Per agevolare il lettore in questo lungo percorso, affascinante ma accidentato, abbiamo pensato di facilitare la sua ricerca o, almeno, di stimolare la sua curiosità inserendo una bibliografia ragionata e in ordine cronologico, al fine di offrire una strumentazione agile ma non troppo stringata su un tema multiforme e impegnativo. Per ulteriori riferimenti bibliografici si rimanda inoltre allo strumento Bibliografia di questo sito.
§.1. L’autore e l’opera
(Eliana Carrara)
C. Plinius Secundus, o, come più comunemente si dice, per distinguerlo dal nipote, Plinio il Vecchio, nacque a Como (Novum Comum) tra il 23 e il 24 d. C. Giunse giovanissimo a Roma, dove iniziò il suo cursus honorum. Ufficiale di cavalleria in Germania, procuratore nella Gallia Narbonese, e poi in Africa, nella Spagna Tarraconese, nella Gallia Belgica, diviene nel 69 d. C. procuratore imperiale a Roma, un altissimo ufficio che lo metteva in continuo contatto con Vespasiano, prefetto della flotta di Miseno. Nella Prefazione della Naturalis Historia, la sua opera più nota (e l’unica a noi giunta tra le altre sue: De iaculatione equestri, De vita Pomponii Secundi, Bella Germaniae, Studiosus, Dubii sermonis libri VIII, A fine Aufidii Bassi), troviamo infatti la dedica a Tito (39-81 d.C.), figlio di Vespasiano.
Clicca qui per maggiori informazioni
Il principio espositivo va dal più importante al meno importante: così, ad esempio, nella sezione dedicata agli animali la suddivisione per classi comincia dall’uomo, mentre in quella dei metalli il primo è l’oro, il secondo l’argento e il terzo il bronzo. In accordo con la concezione della scienza a Roma, rilevante è l’aspetto o meglio la declinazione pratica di ogni sapere e nozione. L’opera enciclopedica di Plinio è dunque una miniera di notizie di geografia, antropologia, zoologia, botanica, botanica medica e zoologia medica e, dal XXXIII al XXXVII, di mineralogia, della lavorazione dei metalli e degli altri materiali impiegati nelle arti: da qui nacque l’esigenza per l’autore latino di scrivere una storia delle arti antiche.
Approfondimenti
Jahn, O. 1850. “Über die Kunsturtheile des Plinius.” Berichte der sächsichen Akademie der Wissenschaften 2: 105-42.
Furtwängler, A. 1877. “Plinius und seine Quellen über die Bildenden Künste.” Jahrbücher für classische Philologie Suppl. 9: 1-78 (= Furtwängler, A. 1912-1913. Kleine Schriften, herausgegeben von J. Sieveking and L. Curtius. Vol. 2, 1-71. München: Beck).
von Urlichs, L. 1878. Die Quellenregister zu Plinius letzen Büchern. Würzburg: Stahel.
Münzer, F. 1895. “Zur Kunstgeschichte des Plinius.” Hermes 30: 499-547.
Jex-Blake, K. and E. Sellers. 1896. The Elder Pliny’s Chapters on the History of Art. London: Macmillan.
Traube, L. 1898. “Zu Plinius Kunstgeschichtlichen Büchern.” Hermes 33: 345-51.
Detlefsen, D. 1901. “Die eigenen Leistungen des Plinius für die Geschichte der Künstler.” JDAI 16: 75-107.
Ferri, S., a cura di 1946. C. Plini Secundi Naturalis Historiae quae pertinent ad artes antiquorum / Plinio il Vecchio, Storia delle arti antiche. Roma: Palombi.
Bieber, M. 1949. “Pliny and Greco-Roman Art.” In Hommages à Joseph Bidez et à Franz Cumont, 39-42. Bruxelles: Latomus
Coulson, W.D.E. 1976. “The Reliability of Pliny’s Chapters on Greek and Roman Sculpture.”, CW 69: 361-72.
Della Corte, F. 1978. “Enciclopedisti latini.” Opuscula 6: 9-107.
Alfonsi, L., a cura di 1982. Plinio il Vecchio sotto il profilo storico e letterario (Atti del convegno, Como, 5-7 ottobre 1979; Atti della tavola rotonda nella ricorrenza centenaria della morte di Plinio il Vecchio, Bologna 16 dicembre 1979). Como: Banca Briantea.
Conte G.B. 1982. “L’inventario del mondo. Forma della natura e progetto enciclopedico nell’opera di Plinio il Vecchio.” In Gaio Plinio Secondo, Storia naturale, a cura di G.B. Conte. Vol. 1, xvii-xlvii. Torino: Einaudi.
Isager, J. 1986. “Plinio il Vecchio e le meraviglie di Roma. Mirabilia in terris e Romae miracula nel XXXVI libro della Naturalis Historia.” ARID 15: 37-50.
Pigealdus J. and J. Orozius, eds. 1987. Pline l’Ancien, témoin de son temps (Conventus Pliniani internationalis, Namneti 22-26 oct. 1985 habiti). Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca.
Isager, J. 1991. Pliny on Art and Society. The Elder Pliny’s Chapters on the History of Art. Odense: Odense University Press.
Baldwin, B. 1995. “The Composition of Pliny’s Natural History.” SO 70: 72-81.
Healy, J.F. 1999. Pliny the Elder on Science and Technology. Oxford: Oxford University Press.
Naas V. 2002. Le projet encyclopédique de Pline l’Ancien. Roma: École française de Rome.
Carey S. 2003. Pliny’s Catalogue of Culture: Art and Empire in the Natural History. Oxford: Oxford University Press.
Melina, G. 2007. “Plinio il Vecchio e la sua storia dell’arte antica.” Ars & Humanitas 1,1: 127-50.
Rouveret, A. 2007. “Ce que Pline l’Ancien dit de la peinture grecque: histoire de l’art ou éloge de Rome?” CRAI: 619-32.
de Angelis, F. 2008. “Pliny the Elder and the Identity of Roman Art.” Res 53-54: 79-92.
Doody, A. 2010. Pliny’s Encyclopedia. The Reception of the Natural History. Cambridge: Cambridge University Press.
Si veda anche la sezione Plinio e l’opera di questo sito web.
§.2. La trasmissione della Naturalis Historia di Plinio dalla tarda Antichità al Medioevo
(Eliana Carrara)
La trasmissione della Naturalis Historia è affidata, per quello che riguarda la tradizione più antica, a pochi manoscritti conservati in porzioni frammentarie. Essi sono i seguenti:
- M = ms. 3.1 (25.2.36; xxv.a.3) della Stiftsbibliothek di St. Paul im Lavanttal (Carinzia), del V secolo d.C.;
- N = ms. Sessoriano 55 della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, del V secolo d.C.;
- O = ms. 1a della Österreichische Nationalbibliothek di Vienna, della metà del V secolo d.C.;
- P = ms. Lat. 9378 (la sola carta 26) della Bibliothèque Nationale di Parigi, della metà del VI secolo d.C.;
- Pal. Chat.= che corrisponde al ms. S 24 (28) della Bibliothèque Municipale di Autun 24 insieme con il ms. Nouv. Acq. Lat. 1629 della Bibliothèque Nationale di Parigi, della metà del V secolo d.C..
In due casi (mss. O e P) essi sono formati da pochissimi fogli di pergamena riutilizzati come materiale per rilegature; negli altri si tratta di palinsesti, ossia di codici scritti due volte dal momento che il supporto scrittorio (generalmente pergamena) veniva eraso per potervi poi scrivervi nuovamente. La porzione più ampia dell’opera di Plinio (libri XI-XV) ci è conservata dal codice palinsesto conosciuto con il nome di Codex Moneus (M), dal nome dello studioso tedesco Franz Josef Mone (1796-1871), conservato nella Stiftsbibliothek di St. Paul im Lavanttal in Carinzia, trattato con reagente chimico per far emergere il testo dell’autore latino.
La tradizione successiva, a partire dall’età altomedievale, è stata divisa dai filologi convenzionalmente in due grandi blocchi in base alla datazione:
- manoscritti vetustiores;
- manoscritti recentiores.
Clicca qui per maggiori informazioni
Fra i recentiores si impone per il peso avuto nell’intera trasmissione del testo di Plinio il codice denominato E dai filologi, il ms. Lat. 6795 della Bibliothèque Nationale di Parigi, di area francese e della seconda metà del IX secolo, mutilo purtroppo dei libri dal XXXII in poi. Dal ms. E derivano tutta un’ampia serie di codici, ovviamente incompleti fra cui spicca il ms. 263 della Bibliothèque Municipale di Le Mans (C), un manoscritto della metà del XII secolo, presumibilmente di area inglese, dallo splendido corredo illustrativo e dalle grandi dimensioni della pagina [Fig. 2]. Dimensioni che divengono quasi standard a partire dal XII secolo, come testimonia anche il codice Arundel 98 della British Library di Londra, databile alla seconda metà del secolo [Fig. 3]. Fra i manoscritti illustrati va poi segnalato per la ricchezza delle sue illustrazioni il ms. R I 5 della Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, databile al 1300 circa e proveniente da Bologna.
Approfondimenti
Detlefsen, D. 1860. “Epilegomena zur Silligschen Ausgabe von Plinius Naturalis historia.” RhM 15: 265-88; 367-90.
Reeve, M.D. 2007. “The Editing of Pliny’s Natural History.” RHT 2: 107-80.
Si veda anche la sezione Manoscritti di questo sito.
§.2.1. I lettori tardoantichi e altomedievali di Plinio
La fortuna dell’opera di Plinio non rimase ancorata ai soli codici che, in forme sempre più lussuose a partire dal tardo Medioevo e con un corredo di immagini che divenne via via ancor più ricco e accurato in pieno Umanesimo, ne tramandarono il testo.
Conobbero e citarono Plinio molti scrittori della tarda Antichità e dell’Alto Medioevo, che dunque contribuirono a diffonderne la fortuna, a patto però di selezioni precise (e mirate) e di un progressivo impoverimento della massa sterminata di notizie trasmesse dai 37 libri della Naturalis Historia.
Così accade per i fortunatissimi Collectanea rerum memorabilium di Solino, vissuto nel III secolo, che centonano in forme rapide e sommarie tutti gli elementi fantastici e meravigliosi dei libri iniziali (III-XIII) nonché del XXXVII dell’opera di Plinio [Fig. 4].
Nella forma di un repertorio alfabetico, organizzato per materie si snodano le Etymologiae di Isidoro di Siviglia (vissuto fra VI e VII secolo), che tramandano notizie sul mondo vegetale, animale e minerale desunte da Plinio (e riversate dall’arcivescovo spagnolo nei libri XV de aedificiis et agris e nel XVI de lapidibus et metallis del proprio testo).
Clicca qui per maggiori informazioni
Se nel Liber lapidum seu de gemmis del dotto vescovo francese Marbodo di Rennes (1035 ca.-1123), un poemetto in esametri latini redatto alla fine dell’XI secolo (forse nel 1096), vengono descritte una sessantina di pietre preziose e le loro virtù magiche e terapeutiche, servendosi tra le altre fonti del libro XXXVII della Naturalis Historia, l’inglese Robert of Cricklade (canonico agostiniano di Cirencester, vissuto nel XII secolo) arrivò a redigere una Defloratio historiae naturalis Plinii, che «depurò» l’opera latina da tutte le contaminazioni pagane, riducendola a soli 9 libri di una summa geografica-naturalistica.
Sempre proveniente dalla colta Inghilterra dei Plantageneti, Bartolomeo Anglico (vissuto nel XIII secolo) redasse verso il 1240 gli ampi 19 libri del De proprietatibus rerum, tradotto poi anche in francese [Fig. 6]; nel libro XVI si sofferma, non certo da tecnico, ma con svelta prosa tutt’al più da osservatore di cantieri medievali, sui materiali da costruzioni e gli elementi utili per la vita quotidiana, De lapidibus et metallis. Va evidenziato, dunque, come solo con uno scrittore attivo in pieno XIII secolo faccia ritorno in un testo che si richiama a Plinio (e tanto più a Isidoro di Siviglia) una qualche forma di interesse per argomenti che costituiscono il fare quotidiano di chi pratichi le arti e le forme di artigianato ad esse collegate.
Notizie tratte da Plinio sono infine presenti nelle più importanti opere a carattere enciclopedico del XIII secolo, quali il Liber de natura rerum, redatto in 19 volumi, fra 1230 e il 1245 circa, dal frate domenicano fiammingo Tommaso di Cantimpré, e lo Speculum maius del domenicano francese Vincenzo di Beauvais, terminato entro il 1244 (anche se successivamente rimaneggiato) e composto di tre parti (Speculum naturale, di 32 libri, Speculum doctrinale, di 17, e Speculum historiale, di 31).
Approfondimenti
Chibnall, M. 1975. “Pliny’s Natural History and the Middle Ages”, in Empire and Aftermath. Silver Latin II, edited by Th.A. Dorey, 57-78. London-Boston: Routledge & Kegan Paul.
Frugoni, C. 1982. “La fortuna di Plinio nel Medioevo e nel Rinascimento.” In Gaio Plinio Secondo, Storia naturale, Cosmologia e geografia Libri 1-6, prefazione di Italo Calvino, saggio introduttivo di Gian Biagio Conte. Vol. 1, lix-lxvi. Torino: Einaudi.
Roncoroni, A. 1982. “Plinio tardoantico.” In Plinio il Vecchio sotto il profilo storico e letterario (Atti del convegno, Como 5-7 ottobre 1979; Atti della tavola rotonda nella ricorrenza centenaria della morte di Plinio il Vecchio, Bologna 16 dicembre 1979), a cura di Alfonsi, 151-68. Como: Banca Briantea.
Roncoroni, A. 1984. “L’eredità di Plinio nel passaggio dal Medioevo all’età moderna.” In Plinio, i suoi luoghi, il suo tempo, a cura della Società archeologica comense, 23-39. Como: Società Archeologica Comense.
Mazzini, I. 1986. “Présence de Pline dans les herbiers de l’antiquité et du haut Moyen Âge.” Helmantica 37,112-114: 83-94.
Oroz Reta, J. 1987. “Présence de Pline dans les ‘Etymologies’ de saint Isidore de Séville.” Helmantica 38,115-117: 295-306.
Codoñer, C. 1991. “De l’Antiquité au Moyen Âge: Isidore de Séville.” In L’encyclopédisme, publié sous la direction d’A. Becq, 19-35. Paris: Klincksieck.
Crikeladensis, R. 2002. Defloratio naturalis historie Plinii secundi, edited by B. Näf. Bern: Lang.
di Rennes, M. 2007. Lapidari. La magia delle pietre preziose, edited by B. Basile. 2nd ed. Roma: Carocci.
Campanale, M.I. 2012. “L’auctoritas di Plinio nelle enciclopedie e nei trattati naturalistici dopo il XII secolo.” In La Naturalis Historia di Plinio nella tradizione medievale e umanistica, a cura di V. Maraglino, 114-30. Bari: Cacucci.
Carnevale, L. 2012. “Plinio e Tommaso d’Aquino tra scienza e fede. Note in margine alla Expositio super Iob ad Litteram, 40-41.” In La Naturalis Historia di Plinio nella tradizione medievale e umanistica, a cura di V. Maraglino, 131-52. Bari: Cacucci.
Mastandrea, P. 2012. “Conoscenza e circolazione del testo a Bisanzio, in età giustinianea.” In La Naturalis Historia di Plinio nella tradizione medievale e umanistica, a cura di V. Maraglino, 9-37. Bari: Cacucci.
Stella, F. 2012. “«Ludibria sibi, nobis miracula». La fortuna medievale della scienza pliniana e l’antropologia della diversitas.” In La Naturalis Historia di Plinio nella tradizione medievale e umanistica, a cura di V. Maraglino, 39-75. Bari: Cacucci.
Tinelli, E. 2012. “La Naturali Historia di Plinio nel De natura rerum di Beda il Venerabile.” In La Naturalis Historia di Plinio nella tradizione medievale e umanistica, a cura di V. Maraglino, 78-104. Bari: Cacucci.
§.2.2. I lettori di Plinio nel Trecento
Sullo scorcio del Medioevo, nella cosiddetta età preumanistica, i libri della Naturalis Historia sono presenti non più soltanto negli scriptoria monastici, cui dobbiamo la trasmissione di molti degli autori classici giunti fino a noi, ma figurano pure negli studioli dei più importanti letterati vissuti nel XIV secolo.
Sappiamo con certezza, grazie ad un appunto redatto sul margine del manoscritto della Bibliothèque Nationale di Parigi, quando Petrarca entrò in possesso di questo testimone frammentario e scorretto dell’opera pliniana: il 6 luglio 1350, mentre si trovava a Mantova [Fig. 7].
L’interesse per Plinio da parte di Petrarca si sarebbe reso tangibile e palese quando venne concretizzato (solo verso il 1366 e dopo molti interventi di limatura e di revisione) il progetto, iniziato nel 1354, del De remediis utriusque fortunae, diviso in due volumi, composti a propria volta da 122 e da 131 dialoghi in cui agiscono come protagonisti alcune figure allegoriche, la Ragione (Ratio), la Gioia (Gaudium), la Speranza (Spes), il Dolore (Dolor) e il Timore (Metus).
Clicca qui per maggiori informazioni
La Naturalis Historia fu ampiamente utilizzata anche da Giovanni Boccaccio nel compilare due fra le sue opere più ampie e di carattere più ambiziosamente erudito, le Genealogie deorum gentilium e il De montibus, silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludibus et de nominibus maris liber. Redatte dagli anni della piena maturità dello scrittore di Certaldo fino a quelli più tardi, esse hanno la forma, rispettivamente, di una vasta enciclopedia in 15 libri sulla genealogia delle divinità e degli eroi dell’Antichità e di un repertorio topografico, organizzato per ‘voci’. Boccaccio poté conoscere Plinio grazie soprattutto alla generosità dell’amico Petrarca, che gli prestò il codice da lui posseduto, il ms. Latinus 6802 della Bibliothèque Nationale di Parigi, come testimoniano le annotazioni di mano dell’autore del Decameron che corrono sui margini del manoscritto, spesso accanto a quelle del proprietario. Le note di Boccaccio palesano, inoltre, lezioni del testo pliniano non presenti nel codice parigino ma che spettano, invece, ad un altro testimone, non ancora identificato, della Naturalis Historia, da cui egli trasse molti passi poi confluiti nello Zibaldone Magliabechiano (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Banco rari 50), un importantissimo documento sulla cultura e sui metodi di lavoro dello scrittore.
Le postille marginali di Petrarca e di Boccaccio costituiscono, dunque, un’attestazione preziosa del tentativo da parte dei due letterati di sanare, per quanto a loro possibile, le numerosissime mende del testo tràdito dell’opera latina, al fine di ottenerne una più proficua comprensione e garantirne una maggiore leggibilità. Sarà questa, non a caso, la grande sfida affrontata dalle generazioni successive di umanisti che, nel corso del Quattrocento, non solo avrebbero affrontato la questione dell’affidabilità dei vari codici a loro disposizione al fine di approntarne un’edizione critica, ma si sarebbero pure incaricati di offrire ad un pubblico di lettori sempre più ampio, grazie alla nascita e alla diffusione della stampa, una versione in volgare della Naturalis Historia.
Approfondimenti
Borst, A. 1994. Das Buch der Naturgeschichte. Plinius und seine Leser im Zeitalter des Pergaments. AbhHeid. Heidelberg: Winter.
Bettini, M. 2002. Francesco Petrarca sulle arti figurative: tra Plinio e Sant’Agostino. Livorno: Sillabe.
Petoletti, M. 2007. “Signa manus mee. Percorso tra postille e opere di Francesco Petrarca.” In L’antiche e le moderne carte. Studi in memoria di Giuseppe Billanovich, a cura di A. Manfredi e C.M. Monti, 451-97. Roma-Padova: Antenore.
Cipolla, S. 2009. “Le ‘mani’ di Petrarca: glosse e disegni autografi del Plinio parigino.” Per leggere 16: 109-56.
Arqués, R. 2010. “L’immagine di Roma fra Petrarca e Boccaccio.” Letteratura & Arte 8: 86-108.
Perucchi, G. 2010. “Le postille di Petrarca a Plinio nel ms. Leiden, BPL 6.” AATC n.s. 61: 65-116.
Perucchi, G. 2013. “Boccaccio geografo lettore del Plinio petrarchesco.” IMU 54: 154–211.
Petoletti, M. 2013. “Boccaccio e Plinio: gli estratti dello Zibaldone Magliabechiano.” Studi sul Boccaccio 41: 257-93.
Reeve, M.D. 2013. “The Text of Boccaccio’s Excerpts from Pliny’s Natural History.” IMU 54: 135-52.
Rosati, G. 2014. “La forma impossibile: le Genealogie e la tradizione mitografica antica.” In Giovanni Boccaccio: tradizione, interpretazione e fortuna. In ricordo di Vittore Branca, a cura di A. Ferracin e M. Venier, 3-17. Udine: Forum.
Rovere, V. 2016. “La struttura e la tradizione manoscritta del De montibus di Giovanni Boccaccio. Prime indagini.” In Nella moltitudine delle cose (Atti del Convegno internazionale su Giovanni Boccaccio a 700 anni dalla nascita, Copenaghen 4 ottobre 2013), a cura di D. Capasso, 122-35. Raleigh: Aonia Edizioni.
§.3. Tradizione manoscritta e circolazione del testo pliniano nel Quattrocento
(Nicoletta Marcelli)
È stato da più parti sottolineato come l’opera di Plinio non sia mai andata perduta né, di conseguenza, sia mai stata riscoperta, come accaduto a molti altri classici dell’antichità agli albori dell’Umanesimo; tuttavia, non sarebbe corretto immaginare la sua trasmissione attraverso i secoli, ivi compreso il Quattrocento, come una linea continua e statica. Piuttosto sembra vero il contrario, per cui la presenza costante della Naturalis Historia nell’orizzonte culturale dell’Europa del Basso Medioevo contrasta con l’impressionante varietà di utilizzo, di fruizione e perfino di valutazione cui fu sottoposta.
Alcune caratteristiche dell’opera ne hanno condizionato sia la ricezione attraverso i secoli sia la sua trasmissione: ad esempio, il fatto più rilevante è che l’opera non fu concepita per essere insegnata nelle scuole, e di fatto non vi entrò mai; in secondo luogo, la divisione in blocchi tematici coerenti ne ha permesso una fruizione per excerpta sulla base degli interessi dei lettori e delle tendenze culturali delle varie epoche. A tutto ciò si aggiunge la oggettiva difficoltà del testo che indusse frequentemente i copisti in errore, al punto che la situazione testuale della Naturalis Historia a tutt’oggi risulta fortemente compromessa da mende e lacune perpetuatesi nel corso dei secoli.
Clicca qui per maggiori informazioni
Sul finire del Medioevo, infatti, già con lo studio di Petrarca (testimoniato dalle sue numerose postille al ms. Latinus 6802 della Bibliothèque Nationale di Parigi, cfr. §. 1.4.), l’approccio cambia. Per gli umanisti, sempre molto sensibili ai problemi linguistici, la Naturalis Historia costituiva una fonte lessicale e letteraria di impareggiabile valore. Plinio difatti attinse pesantemente ed esplicitamente dai primi autori greci e romani, molte delle cui opere sono giunte fino a noi proprio grazie – e talvolta solo – nelle citazioni presenti nella Naturalis Historia. Plinio ha svolto dunque la funzione di repertorio lessicografico quanto mai vasto e al contempo specializzato, in cui reperire termini scientifici non disponibili nella lingua veicolare dell’epoca, cioè il latino medievale, né in altri autori antichi.
Nello studio di Plinio l’introduzione della stampa fu la causa diretta di un grande cambiamento di prospettiva e del proliferare di studi filologici. La Naturalis Historia fu stampata precocemente (l’editio princeps veneziana è del 1469) e conobbe nella seconda metà del secolo numerose altre edizioni compreso il volgarizzamento di Cristoforo Landino. Se i lettori medievali non avevano mostrato particolare disagio nei confronti del testo pliniano nonostante esso fosse infarcito di corruttele e lacune, nella stagione dell’Umanesimo ormai maturo, il problema del restauro testuale della Naturalis Historia divenne cruciale, specie laddove si preparava l’opera per la pubblicazione a stampa e dunque per una sua diffusione ad ampio raggio grazie al nuovo mezzo tecnologico. L’attività emendatoria degli umanisti si basò sia sulla collazione utilizzando manoscritti antichi, sia ricorrendo alla congettura: da questo punto di vista il testo di Plinio ha rappresentato un banco di prova per alcuni dei più importanti eruditi dell’epoca, che posero le fondamenta per la nascita della scienza filologica.
Ma siccome emendare voleva dire anche interpretare e spiegare il testo – specie nel caso della Naturalis Historia particolarmente complesso e a tratti oscuro – l’attività ecdotica fu sovente accompagnata dalla composizione di più o meno sistematici commenti. Un aspetto fondamentale per la diffusione dell’opera è rappresentato dalle numerose epitomi, responsabili spesso della sopravvivenza del testo attraverso i secoli medievali. Se sul piano filologico tali testimonianze occupano un posto secondario ai fini della constitutio textus proprio in virtù del fatto che l’opera nella sua interezza presenta ancora gravi problemi che necessitano di una soluzione, al contrario le epitomi costituiscono un fenomeno altamente rilevante dal punto di vista della storia della tradizione e della diffusione dell’opera nel Basso Medioevo. Tra le più significative, in quanto si presenta come un’abbreviazione che interessa tutti i libri della Naturalis Historia, spicca quella databile al 1422, composta per Paolo Guinigi da Ludovico Guasti.
Resta ancora da fare, e sarebbe quanto mai auspicabile, uno studio mirato sulla tradizione degli excerpta per capire se e in che misura essi abbiano interessato i libri pliniani dedicati alla storia dell’arte prima del moltiplicarsi delle copie integrali dell’opera nel secolo XV. Alla prima metà del Quattrocento sono ascrivibili circa cinquanta manoscritti dell’opera plinana nella sua interezza: il dato, già di per sé significativo in quanto testimonia il vivo interesse per la Naturalis Historia e il crescente numero dei suoi lettori, risulta ancor più rilevante poiché rivela una distribuzione geografica ampia che, per quanto concerne l’ambito italiano, copre di fatto da nord a sud l’intera penisola. Accanto ad aree in cui è documentata la produzione di copie della Naturalis Historia, a volte anche di grande pregio per la lussuosa decorazione, testimonianza di committenza di alto rango, nei maggiori centri di irradiazione dell’Umanesimo quali, ad esempio, Ferrara e Napoli, la trascrizione di nuovi esemplari fu contestuale ad uno studio filologico cui venne sottoposto il testo pliniano oppure ne fu la premessa diretta.
Tra le più significative copie decorate ricordiamo i codici della Malatestiana di Cesena S XI 1, membranaceo, datato 11 ottobre 1446 e S XXIV 5, datato 1451, il primo commissionato da Malatesta Novello, il secondo dal suo medico personale Giovanni di Marco da Rimini; molto interessanti anche i codici sicuramente riferibili all’area di Venezia e Verona (mss. Paris, BNF, Lat. 6806; Paris, BNF, Lat. 6801; Parma, Biblioteca Palatina, Parmense 1278, databile al 1425 circa, la cui decorazione è attribuibile all’artista veneziano Cristoforo Cortese) sempre grazie alla presenza di elementi interni al testo quali subscriptiones dei copisti o gli emblemi dei committenti; non trascurabile neppure la biblioteca federiciana di Urbino in cui spicca il codice BAV, Urb.lat. 245 della metà del ’400.
Nella prima metà del secolo XV il contributo più significativo relativo alle cure filologiche riservate all’opera pliniana e contestualmente alla sua diffusione spetta certamente a Guarino Guarini da Verona. Il suo lavoro sul testo è documentato fin dal soggiorno fiorentino degli anni 1410-1414 come testimoniato dalle postille vergate nel ms. Laurenziano Conventi Soppressi 230 appartenuto ad Antonio Corbinelli presso cui Guarino dimorò in città. È tuttavia consegnato al ms. Ambrosiano D 531 inf., datato 1433, l’esito del suo lavoro coadiuvato da Guglielmo Capello: una nuova “edizione” della Naturalis Historia resa possibile dalla munificenza di Leonello d’Este, marchese di Ferrara e patrono di Guarino. Non è dato di sapere con certezza se a questa impresa editoriale abbia preso parte anche Giovanni Aurispa, come farebbe supporre un accenno contenuto in una lettera che Francesco Filelfo inviò a Niccolò Varrone il 17 novembre 1451, anch’egli alla ricerca di Plinio («emendatissimum Aurispae Guarinique diligentia» Ep. IX 78). In effetti non è da escludere che nel 1445 la richiesta inoltrata da Tommaso Tebaldi, segretario di Filippo Maria Visconti, a Leonello d’Este per avere in prestito un codice di Plinio fosse sì promossa dal duca, ma dietro suggerimento del Tolentinate, il quale all’epoca si trovava già a Milano ed era amico del Tebaldi cui indirizzò varie epistole e a cui dedicò i Convivia Mediolanensia. Com’è noto, Leonello rispose che dei due codici di cui era dotata la sua biblioteca nessuno era al momento disponibile per il prestito e che si doveva attendere il rientro della copia inviata a Cesena, probabilmente usata come testo base per confezionare il codice ultimato nel 1451 per il medico di Malatesta Novello.
I due Plini di cui Leonello parla nella lettera oggi non sono più a Modena: uno dei due potrebbe essere identificabile con quello miniato, definito inamovibile da Leonello e postillato da Guarino per la sua edizione del 1433. Leonello, interpellando l’Aurispa ma con il coinvolgimento probabilmente di altri umanisti, si adoperò per far affluire a corte diversi codici pliniani da mettere a disposizione di Guarino: essi non sono rintracciabili e forse non tutti erano completi, ma è pur sempre molto importante il dato in sé come testimonianza dell’intensa circolazione del testo pliniano a quest’altezza di tempo e in quest’area geografica. Inoltre, la successiva revisione guariniana tràdita dal codice monacense (Clm 11301, datato 1459 testimone di un’ulteriore revisione operata da Guarino poco prima di morire con l’aiuto di Tommaso da Vicenza – copista estense che si sottoscrive nel codice – e dello stesso Capello), attesta l’avvenuto accesso ad altri codici latori di varianti appartenenti a rami diversi della tradizione, il che supporta l’ipotesi che a Ferrara fossero giunti codici pliniani via via sempre migliori, al punto da indurre Guarino ad una seconda revisione del testo terminata solo un anno prima della sua morte.
Il lungo interesse del Veronese per il testo pliniano segnò evidentemente in modo profondo i gusti culturali della corte, tanto che a distanza di alcuni decenni Angelo Decembrio, componendo il dialogo Politia letteraria (libro I par. 7), mise in bocca al duca Leonello, uno degli interlocutori, un lungo discorso su quali fossero i libri più significativi per l’educazione di un gentiluomo e fra di essi spicca proprio Plinio. Ma l’educazione umanistica ricevuta dal giovane duca sotto Guarino e il grande interesse suscitato dal testo di Plinio ebbero effetti tangibili anche nel versante del mecenatismo, per cui Leonello si circondò di artisti quali Pisanello e Cosmè Tura, per i quali sono stati ipotizzati chiari influssi derivanti dall’enciclopedia pliniana.
L’asse Ferrara-Milano per la diffusione di Plinio intorno agli anni Quaranta si inserisce nel quadro di una più vasta circolazione padana e nord italiana che, come abbiamo visto, coinvolge il Veneto e Modena, a testimonianza di un diffuso interesse umanistico-scientifico, almeno nelle corti – quale quella di Malatesta Novello – più attente alla ricerca di testi di difficile reperimento e di un significativo aggiornamento rispetto alle novità librarie umanistiche. Una situazione analoga si registra anche nella raffinata corte dei Gonzaga, in cui il maestro Vittorino da Feltre, grazie anche alla collaborazione con Guarino da Verona, cercò di procurarsi copie di Plinio per la biblioteca di Giovanfrancesco Gonzaga, riuscendoci grazie ai prestiti di altri possessori. Questa fervida circolazione libraria si concretizzò alcuni anni più tardi (1463-1468) con l’allestimento per Ludovico Gonzaga della lussuosa copia – oggi purtroppo gravemente danneggiata – alla cui decorazione e apparato figurativo contribuì forse lo stesso Andrea Mantegna (ms. Torino, Bibl. Nazionale, I.I. 22-23, Fig. 8) negli stessi anni in cui attendeva agli affreschi della Camera picta.
Situazione non dissimile dall’area padana si riscontra alla corte aragonese di Napoli, in cui alla metà del Quattrocento è possibile rintracciare diversi manoscritti appartenuti alla biblioteca di Alfonso il Magnanimo (Holkham Hall, 394; Paris, BNF, Lat. 6804; Valencia, Biblioteca Univ. 691 e 787, quest’ultimo finemente miniato; BAV, Ottob. Lat. 1593-94), mentre sono noti gli interessi suscitati dal testo pliniano in umanisti del calibro di Antonio Panomita (sue tracce sono state rinvenute nella copia già appartenuta a Salutati e a Bruni menzionata più avanti) e di Giovanni Pontano che postillò il codice BAV, Barb. Lat. 143, silloge della seconda metà del Quattrocento, in cui sono documentati i suoi interventi filologici sul testo unitamente ai suoi studi di cosmologia (le annotazioni, infatti, sono concentrate nel libro II della Naturalis Historia).
Un caso a parte nella ricostruzione di questa storia della tradizione è rappresentato dagli altri due principali centri di irradiazione dell’Umanesimo italiano: Firenze e Roma.
Per ciò che concerne la città toscana il ruolo del cancelliere Coluccio Salutati e del celebre bibliofilo Niccolò Niccoli unitamente a Cosimo de’ Medici è fin troppo noto. A Salutati appartenne l’unica copia, benché parziale, dell’opera pliniana (attualmente smembrata in due parti: Oxford, Bodleian Library, Auct. T.I.27 e Paris, Bibliothèque Nationale, Lat. 6798, poi appartenuto a Leonardo Bruni, Antonio Panormita e a Ferrante d’Aragona), presente a Firenze fino agli anni Trenta del Quattrocento insieme col mutilo codice Riccardiano 488 del IX secolo appartenuto al Niccoli. Il primo esemplare completo dell’opera pliniana giunse a Firenze grazie alla rete bancaria di Cosimo il Vecchio, non senza il ruolo determinante giocato proprio da Niccolò Niccoli. Quest’ultimo, infatti, utilizzò per i suoi studi sia il Plinio appartenuto a Salutati sia due copie della propria biblioteca (il già citato Riccardiano 488 originariamente unito al Laurenziano Ashburnham 98 e un’altra copia ad oggi non identificata), ma essendo tutti quegli esemplari incompleti, agì presso Cosimo, affinché si potesse far arrivare a Firenze un esemplare integrale dell’opera. Il progetto andò a buon fine grazie a Gherardo Bueri, il corrispondente del Banco Medici a Lubecca e la copia giunta a Firenze è stata da tempo identificata con i due Plutei della Laurenziana 82, 1 e 82, 2. L’origine nord europea del codice è chiaramente testimoniata dal cartiglio presente in una delle miniature oltre che da una nota di possesso erasa, ma ancora leggibile, in cui si attesta che il libro appartenente ai Domenicani di Lubecca era stato dato in prestito al Bueri per trarne copia. Dai due plutei laurenziani sono discesi altri manoscritti conservati oggi nella medesima biblioteca, fra cui i lussuosi Plutei 82, 3 e 82, 4, commissionati nel 1458 a Vespasiano da Bisticci da Piero di Cosimo, come pure sempre per la famiglia Medici e riferibile alla bottega di Vespasiano è il ms. Harley 2676 della British Library di Londra, trascritto fra il 1465 e il 1467 e destinato alla Badia di Fiesole (Fig. 9). Tra le copie di origine fiorentina di maggiore interesse per la superba decorazione resta, infine, il manoscritto che Pico della Mirandola si fece realizzare nel 1481 dall’illustre copista ferrarese, Niccolò Mascarino, e dal miniatore a tutt’oggi ignoto, chiamato Pico Master (Venezia, Bibl. Naz. Marciana, Lat. VI 245 [2976] Fig. 10, Fig. 11).
Se Firenze fu centro di irradiazione della tradizione manoscritta di Plinio, Roma ebbe un ruolo altrettanto importante nell’ambito della diffusione del testo a stampa. Ovviamente le ragioni di questo fermento editoriale sono da ricercare nella documentata presenza di copie manoscritte nell’Urbe o presso personaggi di spicco gravitanti all’interno dell’ambiente curiale. È il caso, ad esempio, di Enea Silvio Piccolomini, committente del lussuoso BAV Chig. H VIII 260 decorato da Gioacchino de Gigantibus, o del cardinal Bessarione che ordinò la copia pliniana attualmente a Venezia (Marciano Lat. Z 266), o ancora del cardinal Iacopo Ammannati che possedette una copia vendutagli da Pio II nel 1461, da alcuni studiosi identificata con l’esemplare conservato presso il Victoria and Albert Museum di Londra (ms. 1504-1896): il codice fu fatto fare da Goro Lolli Piccolomini, come testimoniato dalla presenza delle sue armi nella lussuosa decorazione, opera di Gioacchino de Gigantibus.
Approfondimenti
Repertori ed opere di carattere generale
Nauert, Ch.G. 1980. “Caius Plinius Secundus.” In Catalogus Translationum et Commentariorum. Mediaeval and Renaissance Latin Translations and Commentaries, edited by P.O. Kristeller, F.E. Cranz and V. Brown. Vol. 4, 297-422. Washington: Catholic University of America Press.
Plinio/Conte = Barchiesi, A., C. Frugoni e G. Ranucci, 1982. “Nota biobibliografica.” In Gaio Plinio Secondo, Storia naturale, I. Cosmologia e geografia Libri 1-6, prefazione di I. Calvino, saggio introduttivo di G.B. Conte, xlix-lxxiv. Torino: Einaudi.
ISTC. The Incunabula Short Title Catalogue. London: The British Library Board.
Edit.16. Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo. Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.
Manus online. Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.
Autori e testi quattrocenteschi
Alberti, L.B. 1989. Reprint. L’architettura [De re edificatoria], traduzione di G. Orlandi, introduzione e note di P. Portoghesi. Milano: Il polifilo.
Bartoli L. ed. 1998. Reprint. Lorenzo Ghiberti, I commentarii (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, II, I, 333). Firenze: Giunti.
Bertolini, L. ed. 2011. Reprint. Leon Battista Alberti, De pictura (redazione volgare). Firenze: Polistampa.
Branca V., and Pastore Stocchi M. eds. 1972. Reprint. Angelo Poliziano, Miscellaneorum centuria secunda. 4 Vols. Firenze: Fratelli Alinari, Istituto di edizioni artistiche.
Calvo, M.F. 1532. Antiquae urbis Romae cum regionibus simulachrum. Roma: Valerius Dorichus Brixiensis.
Charlet, J.-L. ed. 2003. Reprint. Niccolò Perotti, Deux pièces de la controverse humaniste sur Pline: édition critique et commentaire. Sassoferrato: Istituto internazionale di studi piceni.
Donati, G. ed. 2006. L’‘Orthographia’ di Giovanni Tortelli. Messina: Centro Interdipartimetale di Studi umanistici.
Finoli A.M., and Grassi L. eds. 1972. Reprint. Antonio Averlino detto il Filarete Trattato di architettura. 2 Vols. Milano: Il polifilo.
Flavio, B. 1471 (ante 26 luglio). Roma instaurata. Roma: Stampatore di Stazio.
Flavio, B. 1473 (ca.). Roma triumphans. Mantova: Petrus Adam de Michaelibus.
Fulvio, A. 1527 (ca.). Antiquitates Urbis. Roma: Marcello Silber.
Grayson, C. ed. 1972. Reprint. Leon Battista Alberti, De pictura (redazione latina). In Opere volgari, Vol. 3, 7-107. Bari: Laterza.
Landino, L. 1476. Historia naturale di Plinio secondo tradocta di lingua latina in fiorentina. Venezia: Nicholas Jenson.
Martini, F. (di Giorgio), 1967. Reprint. Trattati di architettura, ingegneria e arte militare, a cura di C. Maltese, trascrizione di L. Maltese Degrassi. 2 Vols. Milano: Il polifilo.
Mehus L. ed. 1969. Reprint. Ciriaco d’Ancona, Itinerarium, editionem recensuit animadversionibus ac praefatione illustravit nonnullisque ejusdem Kyriaci epistolis partim editis partim ineditis locupletavit Laurentius Mehus. Bologna: Forni. Originally published in Florentiae: ex novo typographio Joannis Pauli Giovannelli ad insigne palmae, 1742
Merula, G. 1474 (ca.). Emendationes Plinii, Venezia: Johannes de Colonia e Johannes Manthen.
Novati F. ed. 2010. Reprint. Coluccio Salutati, Epistolario. 4 Vols. Roma: Grafica editrice romana (originally published in Roma: Forzani e C. tipografi del Senato, 1891-1911).
Poliziano, A. 1994. Reprint. Miscellaneorum centuria prima. Chiusi: Luì. Originally published in Basileae: apud Nicolaum Episcopium Iuniorem, 1553.
Pontari P. ed. 2011-2017. Reprint. Biondo Flavio, Italia illustrata. 3 Vols. Roma: Istituto storico italiano per il Medio Evo.
Pozzi G. ed. 1973-1974. Reprint. Ermolao Barbaro (the Younger), Castigationes Plinianae et in Pomponium Melam. 4 Vols. Patavii: in aedibus Antenoreis.
Premuda L. ed. 1958. Reprint. Niccolò Leoniceno, De Plinii et plurium aliorum in medicina erroribus liber ad doctissimum virum Angelum Politianum, a cura di L. Premuda. Milano-Roma: Il Giardino di Esculapio.
Studi. Circolazione e tradizione manoscritta del testo pliniano nel Quattrocento
De Marinis, T. 1947. La biblioteca napoletana dei re d’Aragona 2 vols. Milano: Hoepli.
Ullman, B.L. 1963. The Humanism of Coluccio Salutati. Padova: Antenore.
Sabbadini, R. 1964. Reprint. Guariniana: 1. Vita di Guarino veronese, 2. La scuola e gli studi di Guarino veronese, edited by M. Sancipriano. Torino: Bottega d’Erasmo. Original edition, La scuola e gli studi di Guarino Guarini veronese con 44 documenti, Catania: Tip. F. Galati, 1896.
Ruysschaert, J. 1968. “Miniaturistes ‘romains’ sous Pie II.” In Enea Silvio Piccolomini, papa Pio II. Silvio Piccolomini, papa Pio II (Atti del Convegno per il Quinto Centenario della morte e altri scritti), 245-82. Siena: Accademia degli Intronati.
Ullman, B.L. and Ph.A. Stadter, 1972. The Public Library of Renaissance Florence: Niccolò Niccoli, Cosimo de’ Medici and the Library of San Marco. Padova: Antenore.
Di Benedetto, F. 1972. “Il Plinio laurenziano proviene veramente da Lubecca.” In Studi classici in onore di Quintino Cataudella. Vol. 3, 437-45. Catania: Edigraf.
Nauert, Ch.G. 1979. “Humanists, Scientists and Pliny: changing Approaches to a classical Author.” AHR 84,1: 72-85.
Branca, V. 1981. “Poliziano e la libreria medicea di San Marco.” In Miscellanea Augusto Campana. Vol. 1, 167-87. Padova: Antenore.
Armstrong, L. 1983. “The illustration of Pliny’s Historia naturalis: manuscripts before 1430.” JWarb 46: 19-39.
Stadter, Ph.A. 1984. “Niccolò Niccoli: winning back the Knowledge of the Ancient.” In Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Billanovich, a cura di by R. Avesani, M. Ferrari, T. Poffano, G. Frasso e A. Sottili. Vol. 2, 747-64. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
De la Mare, A.C. 1986. “Vespasiano da Bisticci e i copisti fiorentini di Federico.” In Federico di Montefeltro. Lo stato le arti la cultura, a cura di G. Cerboni Baiardi, G. Chittolini e P. Floriani. Vol 3, 81-96. Roma: Bulzoni.
Sconocchia, S. 1986. “Codici di medicina antica della biblioteca di Federico.” In Federico di Montefeltro. Lo stato le arti la cultura, a cura di G. Cerboni Baiardi, G. Chittolini e P. Floriani. Vol 3, 149-73. Roma: Bulzoni.
Cherchi, P. e T. De Robertis, 1990. “Un inventario della biblioteca aragonese.” Italia Medioevale e Umanistica 33: 109-347
Savino, E. 1995. “I due Plinii Naturalis historia della Malatestina.” In Libraria Domini. I manoscritti della Biblioteca Malatestiana: testi e decorazioni, a cura di F. Lollini e P. Lucchi, 103-14. Bologna: Grafis Edizioni.
D’Urso, T. 2002. “Un manifesto del ‘classicismo’ aragonese: il frontespizio della Naturalis historia di Plinio il Vecchio della Biblioteca di Valenza.” Prospettiva 105 (gennaio): 29-50.
Davies, M. 2002. “Per l’esegesi di Plinio nel Quattrocento.” In Nel mondo delle postille, edited by E. Barbieri, 125-52. Milano: C.U.S.L.
Giazzi, E. 2004. “Un episodio della fortuna dei due Plinii fra Trecento e Quattrocento: Domenico Bandini di Arezzo.” In Analecta Brixiana. Contributi dell’Istituto di Filologia e storia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a cura di A. Valvo e G. Manzoni, 49-73. Milano: V&P Strumenti.
Rollo, A. 2004. “Sulle tracce di Antonio Corbinelli.” Studi medievali e umanistici 2: 25-95.
Rinaldi, M. 2006. “Un codice della Naturalis Historia annotato da Giovanni Pontano.” Studi medievali e umanistici 4: 161-202.
Nebbiai-Dalla Guarda, D. 2007. “Lecteurs de Pline l’Ancien du Moyen Age à l’humanisme: l’apport des sources pour l’histoire des bibliothèques.” In Os clássicos no tempo. Plínio, o Velho, e o Humanismo Português (Actas de colóquio internacional Lisboa, 2006, Março, 31), coordenação A.A. Nascimento, 45-64. Lisboa: Centro de Estudos Clássicos.
Reeve, M.D. 2007. “The editing of Pliny’s Natural History.” Revue d’histoire des textes 2: 107-180.
Reeve, M.D. 2007. “The Ambrosiani of Pliny’s Natural History.” In Nuove ricerche su codici in scrittura latina dell’Ambrosiana (Atti del convegno, Milano 6-7 ottobre 2005), a cura di M. Ferrari e M. Navoni, 269-80. Milano: Vita e Pensiero.
Guerrieri, E. 2010. “Spunti filologici dall’Epistolario di Coluccio Salutati.” In Coluccio Salutati e l’invenzione dell’Umanesimo (Atti del convegno internazionale di studi, Firenze 29-31 ottobre 2008), a cura di C. Bianca, 231-81. Roma: Edizioni di storia e letteratura.
Corfiati, C. 2012. “Lettori della Naturalis Historia di Plinio a Napoli nel Rinascimento.” In La Naturalis Historia di Plinio nella tradizione medievale e umanistica, a cura di V. Maraglino, 251-76. Bari: Cacucci.
Reeve, M.D. 2012. “Excerpts from Pliny’s Natural History.” In Ways of approaching Knowledge in late Antiquity and the early middle Ages: Schools and Scholarship, edited by P. Farmhouse Alberto and D. Paniagua, 245-63. Nordhausen: Traugott Bautz.
Fig. 8
Manoscritto pliniano realizzato per Ludovico Gonzaga, 1463-1468. Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria, ms. J.I.22-23, c. 469r.
Fig. 9
Manoscritto riferibile alla bottega di Vespasiano da Bisticci, 1465-1467. Londra, British Library, ms. Harley 2676, f. 19r.
Fig. 10
Manoscritto commissionato da Pico della Mirandola, 1481. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. Lat. VI. 245 (2976), f. 3 (115).
§.3.1. Le imprese editoriali del secondo Quattrocento: il testo di Plinio come «laboratorio filologico»
Com’è noto, la princeps pliniana vide la luce a Venezia nel 1469 (ISTC ip00786000) per i tipi di Giovanni da Spira: sebbene non vi sia alcuna indicazione circa la responsabilità editoriale o la provenienza del testo, è stato appurato che esso deriva dal ms. parigino BNF, Lat. 6805. L’anno successivo a Roma uscì la prima vera edizione critica del testo pliniano curata da Giovanni Andrea Bussi, vescovo di Aleria, che si era avvalso delle competenze di Teodoro Gaza in materia di greco (Sweynheym e Pannartz, ISTC ip00787000, con ristampa veneziana di Nicolaus Jenson nel 1472 ISTC ip00788000).
Le varie fasi della constitutio textus operata dagli editori è ad oggi ricostruita grazie alla sopravvivenza di due dei tre codici utilizzati per la preparazione dell’edizione. Sfortunatamente il pionieristico lavoro all’indomani della sua uscita suscitò un nugolo di critiche che attaccavano la validità delle scelte filologiche compiute, soprattuto relativamente ai numerosi punti in cui il testo pliniano era mendoso ed era stato sottoposto ad interventi emendatori. Uno dei protagonisti di queste polemiche fu, oltre a Giorgio Merula che per primo criticò pesantemente l’operato degli editori (Emendationes in Virgilium et Plinium, 1471), Niccolò Perotti, il quale nel suo violento attacco giunse perfino – forse non a torto – a invocare l’istituzione di una forma di controllo sull’editoria dei classici a Roma.
Clicca qui per maggiori informazioni
Nonostante l’immane lavoro di revisione compiuto, anche il Plinio di Perotti fu passato, per così dire, a fil di spada dalle critiche, in particolare da Domizio Calderini che, con le sue Observationes, segnò un punto di svolta nella filologia umanistica quattrocentesca, adottando un atteggiamento critico nei confronti del fervore delle edizioni a stampa dei classici a Roma: tra l’ottimismo trionfalistico della prima ora e la forte censura di Perotti, Calderini si distinse per una posizione mediana, che fece dell’uso dei manoscritti antichi uno dei suoi strumenti di lavoro privilegiato, sovente accompagnato dal ricorso a testimonianze di fonti parallele.
Il testo pliniano fu nuovamente oggetto di edizione critica a Parma nel 1476 (ISTC ip00790000, ristampata più volte dal 1479 al 1491), operazione fino a qualche tempo fa attribuita a Filippo Beroaldo il Vecchio, ma di recente ascritta a Girolamo Bologni.
Sullo scorcio del secolo, infine, uscirono l’edizione di Giovanni Britannico, stampata dai suoi fratelli Angelo e Giacomo titolari della tipografia (Brescia, 1496, ISTC ip00797000), e quella di Giovan Battista Palmari (Venezia, Bernardino Benalio, 1498, ISTC ip00799000) che includeva anche le preziosissime Castigationes Plinianae di Ermolao Barbaro.
Non c’è dubbio che il capitolo più interessante relativo al testo pliniano e alla sua fortuna sul finire del secolo sia stato rappresentato dall’impegno profuso a livello filologico da Angelo Poliziano e da Ermolao Barbaro nel tentativo di restaurare un testo martoriato dagli errori dei copisti – e talvolta anche degli editori quattrocenteschi – allo scopo di porlo al centro delle discussioni scientifiche, storiche, linguistiche soprattutto sul piano delle corrispondenze tra latino e volgare, impegno titanico cui, come vedremo, contribuì anche Cristoforo Landino con il suo volgarizzamento dell’opera pliniana.
Poliziano, com’è noto, non pubblicò mai un vero e proprio commento alla Naturalis Historia, ma che il suo interesse per quel testo sia stato accesissimo è testimoniato dai molti materiali superstiti, a partire dal lavoro di collazione – operata sull’edizione del 1473 conservata ad Oxford, Bodleian Library, Auct. Q.I.2 e sui codici fiorentini già menzionati Pluteo 82, 1 e 82, 2, Riccardiano 488 e il celebre codice già appartenuto a Salutati e Bruni (Oxford, Bodleian Library, Auct. T. I 27 e Paris, Bibliothèque Nationale, Lat. 6798) – per proseguire con le recollectae per un corso universitario non ufficiale, tenuto su richiesta di alcuni studenti inglesi e portoghesi tra il 1489 e il 1490 (ms. 754 della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco), per approdare, infine, ai capitoli della prima centuria dei Miscellanea che risultarono arricchiti dal confronto-scontro innescato dall’uscita delle Castigationes Plinianae di Ermolao Barbaro.
Il lavoro sull’opera di Plinio non rappresentò solo un ambito entro cui i singoli protagonisti poterono fare sfoggio della loro acribìa filologica, ma costituì una sorta di vero e proprio campo di battaglia entro cui le scuole accademiche difesero strenuamente le loro posizioni metodologicamente contrapposte. Sull’onda delle intense discussioni testuali, lo studio dedicato alla Naturalis Historia nella seconda metà del Quattrocento finì per aprire un altro versante di disputa che dal piano più strettamente ecodotico sfociò nella polemica in seno all’arte medica che vide come protagonista Niccolò da Lonigo, medico e professore allo studio di Ferrara dal 1464. Pur partendo da solide basi filologiche, la prospettiva da cui muoveva il Leoniceno non era tanto quella di restaurare la correttezza del testo in sé, ma di sottoporlo alla verifica dell’esperienza per determinare l’esattezza e l’affidabilità delle teorie pliniane: un approccio insomma più critico nel merito, favorito anche dalla maggiore accessibilità dei testi greci originali su cui era fondato quello pliniano. Nel 1490 il Leoniceno indirizzò a Poliziano la lettera con cui inviava il De Plinii et plurium aliorum in medicina erroribus liber, ricevendone apprezzamenti pur non senza qualche riserva, e nel 1492 fu la volta del De Plini et aliorum in medicina erroribus, sempre indirizzato a Poliziano, in cui il medico metteva in guardia i propri colleghi dall’affidarsi troppo ciecamente al testo antico col rischio di incorrere in effetti disastrosi tanto sul piano delle diagnosi quanto su quello della cura delle malattie. In altre parole, Leoniceno spostò la critica a Plinio dal piano puramente testuale e filologico a quello del contenuto, che necessariamente a suo parere doveva essere sottoposto al vaglio critico, supportato dal confronto con la pratica esperienziale.
Nel 1493, su sollecitazione di Poliziano, si inserì nella disputa Pandolfo Collenuccio che compose la Pliniana defensio adversus Nicolai Leoniceni accusationem, in cui si prendevano in esame i passi della Naturalis Historia additati da Leoniceno come errati per confutare la validità delle argomentazioni di quest’ultimo e al fine di ribadire l’auctoritas assoluta del testo pliniano.
Un capitolo molto importante di questa diatriba fu scritto, com’è noto, da Ermolao Barbaro con le sue Castigationes Plinianae, pubblicate tra il 1492 e il 1493 – proprio negli stessi anni in cui si andava innescando la polemica appena citata: l’umanista nella sua monumentale opera passò al vaglio il testo pliniano per emendarne i circa 5000 loci corrotti, potendo nella maggioranza dei casi imputare le corruttele presenti nel testo agli accidenti di trasmissione o agli errori dei copisti. Il ricorso a molti manoscritti della tradizione gli consentì di restaurare il testo, ma l’aspetto certamente più innovativo del suo lavoro fu il ricorso alle fonti antiche usate da Plinio – per il versante storico artistico, ad esempio, Vitruvio – che gli permisero di intervenire migliorando il testo nel loci in cui la tradizione era compatta nel tramandare l’errore.
Qualche esempio sarà utile per dare un’idea della qualità e della portata del lavoro di Barbaro: il termine “epictylia”, privo di significato diventò il più congruente “epistylia”, cioè gli architravi dell’edificio (NH XXXV xlix 172); oppure l’assurdo “carsatides” si trasformò nel più familiare “caryatides” ovvero le colonne in foggia di donne prigioniere (NH XXXVI iv 23); infine, grazie all’uso che Plinio fa del testo di Vitruvio nel libro XXXVI, Barbaro riuscì a capire che il capitello ionico era un terzo dello spessore della colonna. Il cruciale lavoro dell’umanista costituì, fra le altre cose, anche un ridimensionamento delle critiche avanzate da Niccolò Leoniceno all’opera pliniana, poiché il medico non aveva compreso che molti degli errori da lui ascritti al grande classico dovevano in verità essere attribuiti alla corruzione insita nella tradizione manoscritta e all’imperizia dei copisti. Ma certamente uno degli aspetti più importanti delle Castigationes è rappresentato dalle rettifiche lessicografiche in ambito artistico e di conseguenza il suo enorme impatto circa la corretta interpretazione e ricostruzione degli edifici e delle opere antiche.
Approfondimenti
Sabbadini, R. 1900. “Le edizioni quattrocentistiche della ‘Storia Naturale’ di Plinio.” SIFC 8: 439-48.
Marucchi, A. 1968-1969. “Note sul manoscritto [Vat. lat. 5991] di cui si è servito Giovanni Andrea Bussi per l’edizione di Plinio del 1470.” RHT 15: 175-82.
Casciano, P. 1980. “Il ms. Angelicano 1097, fase preparatoria per l’edizione di Plinio di Sweynheym e Pannartz (Hain 13088).” In Scritture, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Aspetti e problemi (Atti del seminario, 1-2 giugno 1979), a cura di C. Bianca, P. Farenga, G. Lombardi, A.G. Luciani and M. Miglio, 383-94. Città del Vaticano: Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica.
Monfasani, J. 1988. “The First Callfor Press Censorship. Niccolò Perotti, Giovanni Andrea Bussi, Antonio Moreto and the Editing of Pliny’s Natural History.” RnQ 41: 1-31.
Fera, V. 1995. “Un laboratorio filologico di fine Quattrocento: la Naturalis Historia.” In Formative Stages of Classical Traditions: Latin Texts from Antiquity to the Renaissance (Proceedings of a Conference held at Erice, 16-22 October 1993, as the 6th Course of International School for the Study of Written Records), edited by O. Pecere and M.D. Reeve, 435-66. Spoleto: Centro italiano di studi sull’alto Medioevo.
Fera, V. 1996. “Poliziano, Ermolao Barbaro e Plinio.” In Una famiglia veneziana nella storia: i Barbaro (Atti del Convegno di studi in occasione del quinto centenario della morte dell’umanista Ermolao, Venezia 4-6 novembre 1993), a cura di M. Marangoni e M. Pastore Stocchi, 193-234. Venezia: Istituto veneto di scienze, lettere ed arti.
Campanelli, M. 2001. Polemiche e filologia ai primordi della stampa: le Observationes di Domizio Calderini. Roma: Edizioni di storia e letteratura.
Lo Monaco, F. 2002. “Apografi postillati del Poliziano: vicende e fruizioni.” In Talking to the Text: Marginalia from Papyri to Print (Proceedings of a conference held at Erice, 26 September-3 October 1998, as the 12. course of International school for the study of written records), edited by V. Fera, G. Ferraù and S. Rizzo. Vol. 2, 615-48. Messina: Centro interdipartimentale di studi umanistici.
Monti, C.M. 2003. “Matteo Rufo, la patria di Plinio e un manoscritto di dedica passato in tipografia.” In Libri e lettori a Brescia tra Medioevo ed età moderna, edited by V. Grohovaz, 203-54. Brescia: Grafo.
Severi, A. 2010-2011. “Il giovanile cimento di Filippo Beroaldo il Vecchio sulla Naturalis historia di Plinio: la lettera a Niccolò Ravacaldo.” Schede umanistiche 24-25: 81-112.
Charlet, J.-L. 2011. “La réception de l’Histoire Naturelle de Pline dans le Cornu copiae de Nicolas Perotti.” In Pline l’Ancient à la Renaissance Transmission, réception et relecture d’un encyclopédiste antique (Actes du colloque international Besançon 25-28 mars 2009). Vol. 1, 237-58. AIHS 61,1-2, 166-167 (juin-décembre).
Raffarin-Dupuis, A. 2011. “L’Histoire Naturelle de Pline l’Ancien dans le processus de reconstruction de Rome à la Renaissance. Le cas particulier des manuscrits Parisinus Latinus 6798 et 6801.” In Pline l’Ancient à la Renaissance Transmission, réception et relecture d’un encyclopédiste antique (Actes du colloque international Besançon 25-28 mars 2009). Vol. 1, 57-72. AIHS 61,1-2, 166-167 (juin-décembre).
Rozzo, U. 2011. “La fortuna della Naturalis Historia di Plinio nell’editoria del XV secolo.” In Pline l’Ancient à la Renaissance Transmission, réception et relecture d’un encyclopédiste antique (Actes du colloque international Besançon 25-28 mars 2009). Vol. 1, 73-113. AIHS 61,1-2, 166-167 (juin-décembre).
Piras, L.A. 2016. “Le dispute filologiche sulla Naturalis Historia di Plinio in Vecchio fra Quattrocento e Cinquecento.” Schifanoia 50-51: 169-76.
§.3.2. L’antiquaria e la trattatistica d’arte di fronte al testo di Plinio il Vecchio
Ciriaco di Filippo de’ Pizzicolli, detto Ciriaco d’Ancona, è stato il primo italiano del Rinascimento a collegare alcune rovine presenti nei paesi del bacino del Mediterraneo con i passi pliniani. Nelle lettere e negli appunti scritti durante i suoi viaggi identificò alcuni edifici come le meraviglie orientali menzionate nel libro XXXVI della Naturalis Historia e contribuì a contestualizzarle fisicamente, determinandone le dimensioni e abbozzandone le facciate, cosa che sarebbe stata impossibile per i suoi contemporanei che non avevano visitato i siti stessi. Mentre autori della sua stessa generazione, come Alberti e Filarete, fusero diversi passaggi dalla Naturalis Historia, creando edifici compositi per rievocare la magnificenza dell’antichità, Ciriaco, proprio perché ebbe modo di visitare gli edifici descritti da Plinio, ebbe un approccio molto più concreto e visivo al testo antico. Al contrario di altri umanisti che, come lui, viaggiarono verso est e che furono interessati quasi esclusivamente a collezionare manoscritti, Ciriaco fu invece affascinato dagli aspetti architettonici dell’antichità e si dedicò alla loro registrazione su carta sotto forma di descrizione o di disegni. Ciò che lo distingue maggiormente dai contemporanei è l’ampio ricorso alle fonti antiche sulla topografia e sull’architettura del vicino Oriente.
Clicca qui per maggiori informazioni
Per l’importanza della sua opera, che abbraccia le più disparate discipline del sapere, e non ultimo per l’impossibilità di collocare geograficamente la sua figura in un’area ben definita, avendo viaggiato e soggiornato in pressoché tutte le principali corti italiane dell’epoca, un posto privilegiato nel panorama quattrocentesco è occupato da Leon Battista Alberti. Il suo rapporto col testo pliniano è stato certamente serrato e intenso, come si può dedurre dalle oltre 250 occorrenze della Naturalis Historia all’interno delle sue opere, siano esse citazioni dirette o più spesso riecheggiamenti – il dato è ricavabile dalla schedatura effettuata in occasione della mostra dedicata ad Alberti e alla sua biblioteca – e ciò non solo per quel che concerne il De re edificatoria e il De pictura, come sarebbe prevedibile, ma anche per il Theogenius, i Profugiorum ab erumna, le Intercenales, il breve opuscolo Villa e soprattutto i Libri de familia, in cui Plinio è addirittura citato come punto di riferimento per l’erudizione, laddove Leonardo Alberti (libro II, p. 103) si dichiara incapace di rispondere ai quesiti postigli, confessando la propria inadeguatezza e suggerendo di fare ricorso agli autori antichi, fra cui tra i latini, insieme a Cicerone, Varrone, Catone, Columella e Seneca, spicca anche Plinio. Lo speciale rapporto che l’artista intrattenne con Plinio è inoltre dimostrato dal fatto che di tutti i suoi libri, Alberti conferì alla Naturalis Historia un particolare valore lasciandola con specifico legato testamentario all’erede Giovanni di Francesco d’Altobianco e separandola in tal modo al resto della sua biblioteca, destinata insieme alle carte d’archivio a Bernardo Alberti.
Come si accennava prima, la menzione esplicita del grande autore classico è poca cosa rispetto al debito reale che Alberti contrae con la fonte, probabilmente perché l’artista desiderava marcare una distinzione profonda tra sé e il modello, specie se si considera l’intento teorizzatore di Alberti. Ciò è vero soprattutto per quanto concerne la pittura, poiché Leon Battista non ebbe in animo di scrivere una sorta di storia dell’arte sul modello pliniano, bensì un trattato teorico e per questo afferma di prendere a modello direttamente i più antichi esempi greci. Nonostante queste affermazioni di principio, i suoi debiti con la grande enciclopedia antica restano forti e indubitabili, specialmente quando teorizza la superiorità della pittura su tutte le arti e nel far questo i numerosi esempi ed aneddoti portati a supporto del proprio assunto sono direttamente presi da Plinio. Sempre da Plinio deriva l’importanza per il pittore di acquisire la conoscenza di molte e differenti discipline per arrivare poi alla conclusione che la pittura debba essere inclusa nel novero delle moderne arti liberali. Sul versante dell’architettura il rapporto con il modello pliniano si presenta analogo sul piano dell’esplicitazione della fonte – rare le citazioni dirette a fronte di una dipendenza largamente riconoscibile. Alberti mostra di condividere la visione pliniana dell’architettura fondata su principi utilitaristici e sui valori morali della vita civica; infatti, egli utilizza ampiamente Plinio insieme con altre fonti classiche, per presentare l’architettura come un processo sociale e storico ininterrotto a partire dall’antichità romana e condivide col grande classico il concetto che l’architettura pubblica debba essere improntata agli ideali della dignitas e dell’utilitas, mentre l’architettura privata dovrebbe evitare, attraverso la selezione di materiali appropriati, soluzioni in cui si ostenta il lusso a favore di una sempre sorvegliata e sobria eleganza. Plinio, inoltre, svolge un ruolo significativo nella riflessione albertiana relativa alla definizione dell’architetto come individuo dotato di ratio ovvero la capacità intellettuale che, egli sostiene, dovrebbe elevare l’architettura da disciplina meramente meccanica a vera e propria ars liberalis, in questo giungendo a conclusioni non dissimili da quelle del trattato dedicato alla pittura.
Altro artista profondamente influenzato dal testo pliniano fu Lorenzo Ghiberti, il quale nei suoi Commentarii – opera in tre libri rimasta incompiuta – oltre ad una storia dell’arte antica modellata sulla Naturalis Historia scrisse una serie di biografie di artisti celebri a partire da Giotto per terminare proprio con sé stesso. La dipendenza dal grande classico latino, per quanto manchi ancora uno studio sistematico in questo senso, è riscontrabile sia a livello concettuale – ad esempio, per la particolare attenzione che Ghiberti dedica agli aspetti economici dell’arte, perfino ai prezzi del mercato artistico – sia per temi più specifici come quello di utilizzare il criterio delle Olimpiadi quale scansione cronologica in luogo del calendario cristiano. Ma d’altra parte anche il più noto episodio della biografia di Ghiberti, il concorso per la commissione delle Porte del Paradiso del Battistero di Firenze (1400-1401), si svolse, per così dire, sotto l’egida pliniana, dal momento che tanto Palla di Nofri Strozzi quanto Matteo di Giovanni Villani, incaricati in qualità di specialisti delle humanae litterae per affiancare la giuria nella selezione dell’artista, stilarono criteri estetici per la valutazione delle opere dei partecipanti basati in larga parte sul testo della Naturalis Historia; ed è indubbia la familiarità che sia Strozzi sia Villani ebbero col testo pliniano, mentre resta in dubbio se Ghiberti possa avervi avuto accesso già prima di questa cruciale esperienza della sua carriera.
L’interesse suscitato nell’ambiente romano dal testo di Plinio si concentrò prevalentemente su aspetti di carattere antiquario e inerenti allo studio dei mirabilia Urbis allo scopo di sgomberare il campo dall’alone di mistero che avvolgeva ancora molti resti archeologici dell’antica Roma, come testimoniato sia dagli studi di Pomponio Leto e dai membri che gravitavano attorno alla sua Accademia, ma prima ancora dall’opera di Flavio Biondo e, non ultimo, da quella di Giovanni Tortelli, umanista e bibliotecario della Curia, il cui celebre trattato De orthographia denuncia in più punti debiti nei confronti dell’enciclopedia pliniana.
La generazione successiva, in cui tra gli allievi di Pomponio Leto spicca Andrea Fulvio, spostò decisamente il baricentro dell’interesse verso l’architettura, per cui, ad esempio, nelle Antiquitates Urbis di Fulvio il classico latino cessa di essere veicolo di informazioni che suscitano stupore e meraviglia e viene sottoposto ad un’attenzione più sobria e rigorosa, così da diventare fonte di informazioni anche pratiche e maggiormente dettagliate al fine di migliorare la comprensione e la descrizione delle rovine romane.
In linea con questa tradizione, ma rappresentandone in un certo senso l’apice, si pone l’opera di Fabio Calvo, artista proveniente dall’ambiente dell’Accademia pomponiana, amico e collaboratore di Raffaello: nel suo Antiquae urbis Romae cum regionibus simulachrum, sulla base del testo pliniano – come testimoniato dalle annotazioni autografe rinvenute in due copie della Naturalis Historia da lui possedute (BAV, R.I.II.999 = ed. Venezia, 1507; BAV, R.I.V.2247 = ed. Lione, 1510) – confronta la topografia della Roma antica attraverso quattro epoche distinte, adottando un approccio innovativo che, come recenti studi hanno dimostrato, sarebbe stato influenzato dalle idee raffaellesche.
Un altro significativo capitolo del Fortleben pliniano in ambito artistico è rappresentato dall’opera di Antonio di Pietro Averlino, meglio noto col nome di Filarete. Scultore di professione, celebre per le grandi porte bronzee realizzate per la cattedrale di San Pietro a Roma (1433-1455), nel suo Libro architettonico (1460-1464) affronta la disciplina a partire dal cruciale lavoro di Alberti, che mostra di avere assai ben presente. Progettata per essere composta in 24 libri, l’opera di Filarete descrive in modo analitico due città immaginarie, Sforzinda e Plusiapolis, e l’evoluzione della loro costruzione, inframezzando alla narrazione anche parti dialogiche che vedono coinvolti oltre all’autore, il committente e l’archietto. Lungi dal potersi definire un umanista, Filarete intendeva raggiungere l’audience più vasta possibile e a tale scopo ritenne opportuno non solo utilizzare il volgare, ma dotare l’opera anche di disegni e illustrazioni. Non è stato ancora dimostrato come Filarete possa aver avuto accesso ai classici ritenuti all’epoca fondamentali per la conoscenza, quali appunto Plinio, forse consultandoli nella biblioteca della corte di Pavia o piuttosto grazie alla mediazione dell’amico e umanista Francesco Filelfo, anch’egli di stanza presso la corte milanese negli stessi anni; è stato addirittura ipotizzato che la collaborazione tra i due non si limitasse alla segnalazione o al prestito di libri, ma che il Tolentinate abbia fornito anche una traccia per la composizione dell’opera. Del resto è altrettanto dibattuta la questione relativa alla effettiva capacità dell’architetto di fruire del testo direttamente dall’originale latino o non piuttosto attraverso epitomi volgarizzate, soprattutto in considerazione della complessità del testo pliniano che richiedeva ben più di una competenza linguistica di base. Uno degli aspetti più significativi del rapporto di Filarete con Plinio, e che lo differenzia da quello che Alberti intrattenne col grande classico, consiste nell’importanza attribuita alle rovine dei grandi monumenti antichi quale testimonianza della munificenza dei loro patroni. In questo senso, infatti, le descrizioni e i disegni degli edifici eretti a Sforzinda e a Plusiapolis – che occupano la parte più cospicua del trattato – riecheggiano il paradigma secondo cui i governanti acquistano fama e memoria imperitura proprio grazie alle grandi committenze architettoniche, specialmente quelle che si propongono di ridisegnare l’assetto di intere città.
Altra figura di spicco nel panorama dell’epoca fu l’architetto e ingegnere senese Francesco di Giorgio Martini, responsabile di alcuni dei più prestigiosi progetti dell’Italia centrale e settentrionale, quali il Palazzo Ducale di Urbino (1477-1482) e la cupola della Cattedrale di Milano (1490), nonché disegnatore e teorico di notevole levatura, tanto che nei suoi scritti riuscì a spaziare tra ambiti disciplinari assai diversi, occupandosi anche di ingegneria e di questioni militari. Il Trattato di architettura civile e militare segna uno snodo estremamente significativo, soprattutto in relazione al De re aedificatoria di Alberti, sia per ciò che concerne l’aspetto linguistico – scelse difatti il volgare invece del latino – sia per la presenza di illustrazioni, sia, infine, per il contenuto e l’assetto dell’opera, in cui i disegni che accompagnano il testo sono rivolti a proporre soluzioni multiple per ogni tema, caratterizzando l’invenzione architettonica di Francesco di Giorgio come ricca, realistica e fruibile anche per ulteriori rielaborazioni. Sebbene la sua opera ci sia giunta in uno stato piuttosto frammentario, risulta tuttavia chiaro che essa fu sottoposta a varie fasi redazionali, nelle quali la presenza del testo pliniano si intensifica negli stadi finali, mentre resta ancora da appurare se egli avesse posseduto una copia della Naturalis Historia da cui attingere o se i riferimenti al testo siano stati frutto di un processo puramente mnemonico esercitato su fonti secondarie. Nei Principi e norme necessarie e comuni, opera che risale alla fine del 1490, l’artista delinea i vari materiali utilizzati nell’architettura civile e militare a partire dal marmo e poi seguendo un ordine che ricalca molto da vicino quello della sezione del libro XXXVI della Naturalis Historia dedicata alle pietre. Se si volesse individuare un tratto peculiare dell’opera di Francesco di Giorgio rispetto ad Alberti e a Filarete, bisognerebbe sottolineare che mentre i due illustri predecessori avevano attinto dall’opera pliniana prevalentemente racconti di meraviglie naturali, Francesco adottò un approccio più pratico, specie per ciò che riguarda i materiali, omettendone le eventuali proprietà favolose, ma presentandoli piuttosto nel contesto di cave locali, di foreste o altri ambienti facilmente individuabili come risorse che i patroni e gli architetti – il pubblico privilegiato a cui la sua opera si rivolge – avrebbero potuto realisticamente impiegare nei loro progetti.
Approfondimenti
Olivetti, S. 1987. “La Historia Naturalis (XXXV, 116-117) di Plinio il Vecchio, fonte per la decorazione della Loggia del Belvedere di Innocenzo VIII.” Storia dell’arte 59: 5-10.
Conti, A. 1988-1989. “Andrea Mantegna, Pietro Guindaleri ed altri maestri nel ‘Plinio’ di Torino.” Prospettiva 53-56: 264-77.
Pierguidi, S. 2002. “Botticelli and Protogenes: an Anecdote from Pliny’s Naturalis Historia.” Source 21,3: 15-8.
Benigni, P. 2005. “I documenti della biografia albertiana: ciò che sappiamo e ciò che resta da fare.” In Leon Battista Alberti: la biblioteca di un umanista, a cura di R. Cardini, con la collaborazione di L. Bertolini e M. Regoliosi, 37-8 e scheda n. 12. Firenze: Mandragora.
Bert, M. 2005. “Alberti et Pline: l’éloge de la peinture.” Albertiana 8: 227-38.
Cardini, R. a cura di, 2005. Leon Battista Alberti: la biblioteca di un umanista, con la collaborazione di L. Bertolini e M. Regoliosi. Firenze: Mandragora.
Bulgarelli, M. et al., a cura di, 2006. Leon Battista Alberti e l’architettura. Cinisello Balsamo: Silvana.
Carrara, E. 2011. “Plinio e l’arte degli Antichi e dei Moderni. Ricezione e fortuna dei libri XXXIV-XXXVI della Naturalis Historia nella Firenze del XVI secolo (dall’Anonimo Magliabechiano a Vasari).” In Pline l’Ancient à la Renaissance. Transmission, réception et relecture d’un encyclopédiste antique (Actes du colloque international Besançon 25-28 mars 2009). Vol. 1, 367-81. AIHS 61,1-2, 166-167 (juin-décembre).
Blake McHam, S. 2013. Pliny and the Artistic Culture of the Italian Renaissance. The Legacy of the Natural History. New Haven and London: Yale University Press.
Bert, M. 2014. “Entre refus et emulation Alberti face à l’Histoire naturelle de Pline dans le ‘De picture’.” Albertiana 17: 53-93.
Fane-Saunders, P. 2016. Pliny the Elder and the Emergence of Renaissance Architecture. New York: Cambridge University Press.
§.3.3. Il volgarizzamento di Cristoforo Landino: tra politica culturale e avanguardia lessicografica
L’imponente opera di traduzione intrapresa da Cristoforo Landino ebbe una durata sorprendentemente breve, giacché iniziò verosimilmente nella primavera del 1474 ed era certamente terminata il 20 agosto del 1475, come si evince dalla lettera di Niccolò Bendedei, ambasciatore di Ercole d’Este a Firenze, inviata proprio in quella data in patria, in cui si menziona l’opera di Landino come già conclusa. Il volgarizzamento fu commissionato all’umanista di Pratovecchio dal re Ferdinando d’Aragona che intendeva inviarlo in dono a Carlo Temerario, duca di Borgogna, in occasione del fidanzamento tra il proprio figlio, Federico d’Aragona, e Maria di Borgogna, erede unica di Carlo. Questa committenza di alto rango è documentata dai due manoscritti di dedica oggi conservati a El Escorial (Real Biblioteca de San Lorenzo, h I 2 [libri 19-37] e h I 3 [libri 1-18]), nei quali sono state rintracciate correzioni autografe dell’autore.
L’anno successivo (1476) l’opera fu stampata in 1000 esemplari dal tipografo veneziano Nicholas Jenson, grazie all’intervento di Girolamo Strozzi, il quale pagò al Landino 50 fiorini d’oro, ma va da sé che l’impresa dello Strozzi da sola non sarebbe stata sufficiente a supportare finanziariamente un’opera così imponente, anche per la tiratura di copie previste, per cui la dedica a Ferrante d’Aragona dovette sicuramente avere anche uno scopo economico che andava al di là del compenso per l’autore del volgarizzamento e per l’allestimento dei codici di dedica.
Clicca qui per maggiori informazioni
Non è difficile intuire i motivi che spinsero l’umanista di Pratovecchio ad accettare l’ardua impresa di volgarizzare un testo che si presentava irto di difficoltà sintattiche e morfologiche, nonché di scogli lessicali difficili da superare (per non parlare della scarsa affidabilità del testo latino di cui allora si disponeva). Oltre ad essere una delle più importanti, se non la più importante, enciclopedia del sapere antico, la ragione è senza dubbio da ricercarsi nell’interesse che Landino nutriva per lo sviluppo e il potenziamento del volgare: come si evince dalla prolusione al corso da lui tenuto intorno al 1467 sui Rerum vulgarium fragmenta di Petrarca, la lingua fiorentina era una delle più ricche dal punto di vista lessicale e godeva di una prestigiosa reputazione derivantegli dall’opera delle Tre Corone; successivamente, tuttavia, al volgare aveva nuociuto la penuria di scrittori che lo illustrassero con la loro opera. La consapevolezza della superiorità della lingua fiorentina – e con essa della politica e della cultura in senso più lato – è presente difatti nel proemio al volgarizzamento indirizzato a Ferdinando d’Aragona, a cui viene riconosciuto il merito di aver fatto sì che Plinio diventasse da latino fiorentino, in tal modo permettendo a tutti coloro che erano ignari della “grammatica” di accedere ad un’opera cruciale per il sapere; ma con tale operazione appariva anche chiaro che si veniva a stabilire il primato culturale di Firenze nel panorama europeo, per cui il fiorentino assurgeva al rango di lingua veicolare della cultura e per questo fruibile da tutti i dotti italiani e stranieri. L’operazione di Landino, in ultima analisi, è da inscriversi nell’ambito della strategia di politica culturale laurenziana che caratterizzò l’epoca del Magnifico fino alla sua morte.
Per Landino l’esegesi del testo classico non passò mai attraverso la via della ricerca filologica o erudita, né attarverso la meticolosa analisi dei riferimenti storici, poiché l’opera costituiva un vivo modello, soprattutto retorico e stilistico (ma anche etico, come nel caso di Virgilio e di Dante), che si offriva al modemo scrittore, affinché divenisse oggetto di imitazione. L’attitudine del Landino nei confronti dell’ipotesto pliniano rispecchia questa scelta di campo: egli, infatti, non sottopose mai l’originale latino a sua disposizione ad un vaglio critico, neppure quando esso presentava mende talmente gravi da impedire una traduzione dotata di senso compiuto. A ciò si aggiunga che, non di rado, anche laddove il testo latino era corretto, il Landino incorse in gravi fraintendimenti, sovente tali e di tale natura da far sorgere dubbi sull’identità del volgarizzatore.
Ma a dispetto dei suoi limiti e degli errori, a volte grossolani, e nonostante le aspre critiche che si attirò, soprattutto da parte dell’umanista napoletano Giovanni Brancati, si può affermare che la traduzione pliniana di Cristoforo Landino sia pienamente riuscita nell’intento di accrescere la ricchezza semantica del fiorentino, dotando la lingua volgare di quel lessico specialistico che ancora le mancava per competere a pieno titolo con le lingue classiche e costituire, anzi, un’alternativa di pari dignità. Infatti, sebbene manchino studi specifici sull’argomento, già da alcuni primi spogli effettuati a campione è possibile verificare che molti termini tecnici – in particolare per il lessico zoologico, ittico e botanico – si trovano attestati per la prima volta proprio nel volgarizzamento landiniano e spesso risultano perfino assenti dai lessici e dizionari di riferimento. Il lavoro pionieristico di Landino eseguito a livello lessicografico costituisce indubitabilmente uno dei aspetti di maggior rilievo dell’opera, che offrì un valido punto di riferimento anche a Poliziano, il quale nelle Recollectae al corso sulla Naturalis Historia ricorse proprio all’impiego di volgarismi corrispondenti ai termini latini come strumento interpretativo del testo pliniano.
Approfondimenti
Gentile, S., a cura di 1974. Caio Plinio Secondo, La ‘Storia Naturale’ [Libri I-XI] tradotta in «napolitano misto» da Giovanni Brancati. Napoli: s.i.t.
Fubini, R. 1995. “Cristoforo Landino, le Disputationes camaldulenses e il volgarizzamento di Plinio: questioni di cronologia e di interpretazione.” In Studi in onore di Arnaldo d’Addario, a cura di L. Borgia et al. Vol. 2, 535-57. Lecce: Conte.
Antonazzo, A. 2010-2011. “I codici di dedica del volgarizzamento pliniano di Cristoforo Landino: una revisione autografa.” SMU 8-9: 343-65.
Antonazzo, A. 2018. Il volgarizzamento pliniano di Cristoforo Landino. Percorsi dei classici 22. Messina: Centro Internazionale di Studi Umanistici.
Marcelli, N. 2011. “La Naturalis Historia di Plinio nel volgarizzamento di Cristoforo Landino”. In Pline l’Ancient à la Renaissance. Transmission, réception et relecture d’un encyclopédiste antique (Actes du colloque international Besançon 25-28 mars 2009). Vol. 1, 137-61. AIHS 61,1-2, 166-167 (juin-décembre).
§.4. Il Cinquecento. La fortuna cinquecentesca della Naturalis Historia
(Eliana Carrara)
Nel gennaio del 1506, in una vigna sul colle Oppio, nei pressi del Colosseo, venne ritrovato il gruppo scultoreo del Laocoonte, di cui narra diffusamente Plinio nel libro XXXVI (capitolo 38) della Naturalis Historia, che ne ricordava la sua collocazione all’interno del palazzo dell’imperatore Tito. La riscoperta della celeberrima opera antica conferì un’ulteriore, e anzi ormai un’indiscutibile, autorevolezza al testo dello scrittore latino e determinò un accrescersi della sua già fiorente fortuna e diffusione presso il colto mondo dei letterati e degli umanisti e, a maggior ragione, anche presso gli artisti, che poterono consultare facilmente la fonte classica in virtù della vasta disponibilità di edizioni della Naturalis Historia in volgare.
Clicca qui per maggiori informazioni
Un altro elemento importante che segna profondamente la circolazione dell’opera di Plinio è dato dalle dimensioni dei volumi a stampa. L’edizione del 1516 presenta ancora un formato in folio, ossia con le carte del volume che superano i 38 cm, misure che non si differenziavano molto da quelle dei manoscritti, spesso splendidamente illustrati, che era possibile consultare nelle biblioteche dei conventi, come nel codice di Le Mans [Fig. 2] o nel ms. Arundel 98 della British Library di Londra, sempre del XII secolo [Fig. 3], oppure delle prime stampe possedute da facoltosi letterati e colti uomini di governo, come l’incunabolo con il testo in lingua latina, edito a Venezia da Jenson nel 1472 [Fig. 14].
A partire, però, dagli anni Trenta del Cinquecento il testo di Plinio venne stampato in formato in quarto (ossia con misure dell’altezza della pagina che non devono superare i 38 cm e non essere inferiore ai 28): ne è testimone l’edizione pubblicata nel 1534 da Tommaso Ballarino, e assai diffusa, come confermano le copie conservate alla Biblioteca del Museo Galileo di Firenze e alla Nazionale di Roma. E altrettanto diffusa fu la versione a cura di Brucioli del volgarizzamento di Landino edita nel 1543, come attestano gli esemplari della Biblioteca Salvador Pallarés di Valencia, della Complutense di Madrid e quello della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera: un’edizione caratterizzata da un ampio e puntuale indice e le cui dimensioni non erano molto difformi dal manoscritto di Plinio appartenuto al Petrarca, che la acquistò in uno dei suoi viaggi nel Nord Italia, nel corso del 1350 e che si trova ora nella Bibliothèque Nationale di Parigi: esso misura 328 x 235 mm [Fig. 7]. Per non parlare della stampa del 1548, che contiene il volgarizzamento ad opera del Brucioli e che si presenta in un agile formato in 8° (ossia meno di 28 e più di 20 cm).
Sono proprio i tre fattori fin qui esaminati (ossia un volgarizzamento ad opera di un letterato prestigioso, le dimensioni e, quindi, i costi via via sempre più ridotti del libro e, infine, ultimo ma non ultimo, la presenza di indici capillari e di rapida e perspicua consultazione, tratti ancora una volta dall’edizione del 1543) che fecero sì che il testo pliniano ebbe una diffusione veramente pervasiva. A testimoniare la facile accessibilità di tale fonte citeremo un esempio lampante di travaso del testo dello scrittore latino nella prosa brillante del Cortegiano di Baldassarre Castiglione, pubblicato nel 1528 a Venezia, presso Aldo Manuzio (libro I, capitolo LII)
Qui potrei dirvi le contenzioni di molti nobili pittori con tanta laude e maraviglia quasi del mondo; potrei dirvi con quanta solennità gli imperadori antichi ornavano di pitture i lor triunfi e ne’ lochi publici le dedicavano, e come care le comparavano; e che siansi già trovati alcuni pittori che donavano l’opere sue, parendo loro che non bastasse oro né argento per pagarle; e come tanto pregiata fusse una tavola di Protogene che, essendo Demetrio a campo a Rodi, e possendo intrar dentro appiccandole il foco dalla banda dove sapeva che era quella tavola, per non abbrusciarla restò di darle la battaglia e così non prese la terra [XXXV 104]; e Metrodoro, filosofo e pittore eccellentissimo, esser stato da’ Ateniesi mandato a Lucio Paulo per ammaestrargli i figlioli ed ornargli il triunfo che a far avea [XXXV 135]. E molti nobili scrittori hanno ancora di questa arte scritto; il che è assai gran segno per dimostrare in quanta estimazione ella fosse; ma non voglio che in questo ragionamento più ci estendiamo.
La definizione di Metrodoro («filosofo e pittore») venne mutuata paro paro in una lettera molto ampia e molto compiaciuta che Pietro Aretino, il letterato toscano di nascita ma veneziano di adozione, inviava a Giorgio Vasari nel giugno del 1536, per ringraziarlo della descrizione fornitagli – tramite una sua precedente missiva – dell’entrata dell’imperatore Carlo V in Firenze: il giovane pittore era stato fra gli artisti impegnati nell’allestimento dell’imponente serie di monumenti effimeri voluti dall’allora Duca di Firenze, Alessandro de’ Medici:
Pietro Aretino a messer Giorgio d’Arezzo pittore: Se, da poi che Xerse re fu vinto, voi foste stato, quando Paolo mandò agli Ateniesi per un filosofo, che gli amaestrasse i figliuoli, e per un pittore, che gli ornasse il carro, gli averieno inviato voi e non Metrodoro: perché sete istorico, poeta, filosofo e pittore. E ci son di quelli, che gli par esser il seicento fra gli spiriti famosi, che non acozzerebbono in mille anni l’ordine del trionfo cesareo, né la pompa de le genti e de gli archi con la destrezza de le ornate parole, come m’avete scritto.
Ma le occorrenze del Metrodoro di pliniana memoria non si fermano qui. Nel volume che Benedetto Varchi, filosofo e storico fiorentino, diede alle stampe nel 1547 presso Torrentino, con il titolo Lezzione nella quale si disputa della maggioranza delle arti e qual sia più nobile, la scultura o la pittura, si può leggere quanto segue:
Dicono [scil. i pittori] ancora che Demetrio fu non meno grande pittore che filosofo, e che in Atene anticamente fu uno chiamato Metrodoro, il quale fu non solamente pittore grandissimo, ma eccellentissimo filosofo; onde, avendo Lucio Paulo, vinto ch’egli ebbe Perseo, fatto intendere agli Ateniesi che gli mandassero il miglior filosofo che potessero, per insegnare a’ suoi figliuoli, et uno pittore medesimamente eccellentissimo che gli dipignesse il suo trionfo, gli Ateniesi gli mandarono Metrodoro, faccendogli a sapere che egli solo lo servirebbe in amendue quelle cose eccellentissimamente. Il che seguì, perciocché Paulo non solo se ne tenne pago e contento fra sé medesimo, ma lo bandì publicamente (p. 36).
La fortuna di Metrodoro, e più in generale del testo di Plinio, costituisce in tal modo una costante e una decisa impronta nella discussione sulle lettere e sulle arti della prima metà del Cinquecento e trova una matrice certa nel De Pictura di Leon Battista Alberti. Dedicato nella versione in volgare a Filippo Brunelleschi, il trattato menziona, nel secondo dei suoi tre libri, Metrodoro, laddove ricorda che:
[i buoni cittadini romani] voleano che i figliuoli bene allevati insieme con geometria e musica imparassono dipignere. Anzi fu ancora alle femine onore sapere dipignere. Marzia, figliuola di Varrone, si loda appresso degli scrittori che seppe dipignere [II, 27-28].
Alla luce di queste considerazioni, acquista ulteriore importanza quanto Vasari riporta all’interno della sua Autobiografia, redatta per la seconda edizione delle Vite, apparse nel 1568 presso i Giunti di Firenze. Rammentando le colte discussioni avvenute alla corte del cardinale Farnese, il pittore ricorda come Paolo Giovio, lo storico comasco, che aveva cominciato a scrivere in latino le Vite di Michelangelo, Leonardo e Raffaello, lo spronasse, invece, a redigere l’opera poi stampata per la prima volta nel 1550, da Torrentino, a Firenze, con la seguente motivazione:
Giorgio mio, voglio che prendiate voi questa fatica di distendere il tutto in quel modo che ottimamente veggio saprete fare, perciò che a me non dà il cuore, non conoscendo le maniere, né sapendo molti particolari che potrete sapere voi: sanzaché, quando pure io facessi, farei il più più un trattatetto simile a quello di Plinio. Fate quel ch’io vi dico, Vasari, perché veggio che è per riuscirvi bellissimo, che saggio dato me ne avete in questa narrazione (Vasari/BB, VI, pp. 389-390).
Un brano, quello appena citato, che compare solo nella stesura del 1568, quando Vasari può parlare anche della propria vita e carriera artistica, entrambe ormai avanzate, ma che richiama un passo presente fin dalla prima edizione del 1550, all’interno del Proemio della seconda parte delle Vite:
E perché nel principio di queste Vite io parlai de la nobiltà et antichità di esse arti quanto a questo proposito si richiedeva, lasciando a parte molte cose – ché io mi sarei potuto servire di Plinio e d’altri autori, se io non avessi voluto, contra la credenza forse di molti, lasciar libero a ciascheduno il vedere le altrui fantasie ne’ proprii fonti -, mi pare che e’ si convenga fare al presente quello che, fuggendo il tedio e la lunghezza, mortal nemica della attenzione, non mi fu lecito fare allora, cioè aprire più diligentemente l’animo et intenzione mia, e mostrare a che fine io abbia diviso questo corpo delle Vite in tre parti (Vasari/BB, III, p. 6).
Plinio, insomma, può trasmettere notizie utili per riaffermare – sull’esempio degli antichi – la supremazia della pittura o della scultura in anni, la fine del quinto decennio del Cinquecento, davvero cruciali per l’affermazione di uno statuto sociale elevato degli artisti, ma non può, ovviamente, fornire alcuna indicazione su quello che è il nuovo metro di giudizio che Vasari vuole imporre, anche tramite la suddivisione delle Vite in tre parti: la qualità dello stile, con la piena consacrazione della bellezza della Maniera moderna. Maniera moderna che è tale e che è migliore delle altre dell’età medievale e di quella pure buona degli artisti del Quattrocento perché ha saputo recuperare proprio la peculiare capacità degli Antichi di imitare la natura, ed in particolare il corpo umano e le sue membra, come spiega con dovizia Vasari nel Proemio della terza parte delle Vite, che rimane uguale nelle due edizioni, la Torrentiniana del 1550 e la Giuntina del 1568:
Il disegno fu lo imitare il più bello della natura in tutte le figure, così scolpite come dipinte: la qual parte viene da lo avere la mano e l’ingegno che raporti tutto quello che vede l’occhio in sul piano, o disegni o in su fogli o tavola o altro piano giustissimo et apunto; e così di rilievo nella scultura. […] Quella fine e quel certo che, che ci mancava, non lo potevan mettere così presto in atto, avvengaché lo studio insecchisce la maniera, quando egli è preso per terminare i fini in quel modo. Bene lo trovaron poi dopo loro gli altri, nel veder cavar fuora di terra certe anticaglie citate da Plinio de le più famose: il Lacoonte, l’Ercole et il Torso grosso di Belvedere, così la Venere, la Cleopatra, lo Apollo, et infinite altre, le quali nella lor dolcezza e nelle lor asprezze, con termini carnosi e cavati da [558] le maggior’ bellezze del vivo, con certi atti che non in tutto si storcono ma si vanno in certe parti movendo, si mostrano con una graziosissima grazia, e furono cagione di levar via una certa maniera secca e cruda e tagliente, che per lo soverchio studio avevano lasciata in questa arte Pietro della Francesca, Lazaro Vasari, Alesso Baldovinetti, Andrea dal Castagno, Pesello, Ercole Ferrarese, Giovan Bellini, Cosimo Rosselli, l’Abate di San Clemente, Domenico del Ghirlandaio, Sandro Botticello, Andrea Mantegna, Filippo e Luca Signorello; i quali, per sforzarsi, cercavano fare l’impossibile dell’arte con le fatiche, e massime negli scórti e nelle vedute spiacevoli, che, sì come erano a loro dure a condurle, così erano aspre e difficili agli occhi di chi le guardava; et ancora che la maggior parte fussino ben disegnate e senza errori, vi mancava pure uno spirito di prontezza, che non ci si vede mai, et una dolcezza ne’ colori unita, che la cominciò ad usare nelle cose sue il Francia Bolognese e Pietro Perugino; et i popoli nel vederla corsero come matti a questa bellezza nuova e più viva, parendo loro assolutamente che e’ non si potesse già mai far meglio (Vasari/BB, IV, pp. 5 e 7-8).
Il nome di Plinio ritorna, poi, nelle Vite, e sempre in entrambe le edizioni, laddove si tratta della rivalità fra pittura e scultura, come nel Proemio di tutta l’opera, quando a sostenere le proprie tesi sono gli scultori:
Vogliano eziandio che il minor numero loro, non solo degli artefici eccellenti ma degli ordinarî, rispetto allo infinito numero de’ pittori, arguisca la loro maggiore nobilità, dicendo che la scultura vuole una certa migliore disposizione e di animo e di corpo, il che rado si truova congiunto insieme, dove la pittura si contenta d’ogni debole complessione, purché abbia la man sicura se non gagliarda; e che questo intendimento loro si pruova similmente da’ maggior’ pregi citati particularmente da Plinio, dagli amori causati dalla maravigliosa bellezza di alcune statue, e dal giudizio di colui che fece la statua della Scultura di oro e quella della Pittura d’argento e pose quella alla destra e questa alla sinistra (Vasari/BB, I, p. 13).
I casi, adombrati, di Pigmalione (per il tramite delle Metamorfosi di Ovidio, libro X, versi 243-297, ma si veda anche la Naturalis Historia, XXXVI, 12) o della Venere di Cnido (Naturalis Historia, XXXVI, 20-21) devono servire a ribadire la superiore fama nell’antichità delle opere scultoree su quelle pittoriche, al fine di riaffermare tale supremazia anche nel presente. Oppure, infine, si fa ricorso a Plinio, sempre in entrambe le edizioni, nel Proemio delle Vite, laddove Vasari traccia un rapido abbozzo della nascita delle arti nel mondo antico, e in particolare della pittura:
[…] secondo che scrive Plinio, questa arte venne in Egitto da Gige Lidio, il quale, essendo al fuoco e l’ombra di se medesimo riguardando, sùbito con un carbone in mano contornò se stesso nel muro; e da quella età, per un tempo, le sole linee si costumò mettere in opera senza corpi di colore, sì come afferma il medesimo Plinio; la qual cosa da Filocle Egizzio con più fatica e similmente da Cleante et Ardice Corintio e da Telefane Sicionio fo ritrovata (Vasari/BB, II, pp. 7-8).
Solo nell’edizione del 1568 compare il riferimento all’autore latino grazie alla nota esortazione ad evitare la troppa diligenza, come leggiamo nella Vita di Luca della Robbia, cui venne commissionato dagli Operai dell’Opera del Duomo di Firenze
[…] l’ornamento di marmo dell’organo che grandissimo faceva allora far l’Opera, per metterlo sopra la porta della sagrestia di detto tempio […]; tutta l’opera […] fu tenuta cosa rara: se bene Donatello, che poi fece l’ornamento dell’altro organo che è dirimpetto a questo, fece il suo con molto più giudizio e pratica che non aveva fatto Luca, come si dirà al luogo suo, per avere egli quell’opera con dotta quasi tutta in bozze e non finita pulitamente, acciò che apparisse di lontano assai meglio, come fa, che quella di Luca; la quale, se bene è fatta con buon disegno e diligenza, ella fa nondimeno con la sua pulitezza e finimento che l’occhio per la lontananza la perde e non la scorge bene come si fa quella di Donato, quasi solamente abbozzata. Alla quale cosa deono molto avere avvertenza gl’artefici, perciò che la sperienza fa conoscere che tutte le cose che vanno lontane – o siano pitture o siano sculture o qualsivoglia altra somigliante cosa – hanno più fierezza e maggior forza se sono una bella bozza che se sono finite; et oltre che la lontananza fa questo effetto, pare anco che nelle bozze molte volte, nascendo in un sùbito dal furore dell’arte, si sprima il suo concetto in pochi colpi, e che per contrario lo stento e la troppa diligenza alcuna fiata toglia la forza et il sapere a coloro che non sanno mai levare le mani dall’opera che fanno (Vasari/BB, III, p. 51-52).
Il confronto fra le opere dei due scultori del primo Quattrocento e sulla diversa resa del loro modellato, che risulta ben evidente anche ai nostri occhi, pur essendo i due monumenti da tempo smantellati e fortemente manomessi [Luca della Robbia, Donatello], viene brillantemente sintetizzato da Vasari grazie alla formula Manum tollere che egli trovava legato a un grande artista dell’antichità, in un passo del libro XXXV, capitolo 80, della Naturalis Historia, ossia Apelle che manum de tabula sciret tollere. E solo nell’edizione apparsa presso i Giunti a Firenze nel 1568 possiamo leggere il brano che segue perché esso figura all’interno della Vita di Marcantonio Bolognese e d’altri intagliatori di stampe, fra i quali compare anche il medaglista e incisore Enea Vico, scomparso nel 1567. Scrive dunque Vasari a proposito di quest’ultimo:
chi l’ha tassato ne’ libri delle medaglie, ha avuto il torto, perciò che chi considererà le fatiche che ha fatto, e quanto siano utili e belle, lo scuserà se in qualche cosa di non molta importanza avesse fallato; e quelli errori che non si fanno se non per male informazioni, o per troppo credere o avere, con qualche ragione, diversa openione dagl’altri, sono degni di esser scusati, perché di così fatti errori hanno fatto Aristotile, Plinio e molti altri (Vasari/BB, V, p. 19).
L’Auctoritas di Plinio sta così alla pari con Aristotele e con altri grandi scrittori del passato; e se l’autore della Naturalis Historia può aver sbagliato e gli va usata comprensione, allo stesso modo devono essere perdonati coloro che commettono sbagli mentre ora redigono opere di grande impegno e di ampia trattazione. È implicito e neppure troppo velato l’accenno alle critiche ricevute dopo la comparsa della prima edizione delle Vite nel 1550, che non solo erano state subissate di accuse da parte dei difensori di Tiziano e di tutta la pittura del Nord d’Italia (poco presente nella redazione torrentiniana) ma avevano dovuto annoverare tra i più accesi detrattori lo stesso Michelangelo, fortemente irritato per alcune imprecisioni vasariane nella propria biografia. Significativi, in effetti, furono i cambiamenti, le integrazioni e gli addenda inseriti nella seconda edizione apparsa presso i Giunti di Firenze nel 1568 [Fig. 15], che risultò molto più ampia della prima per il numero degli artisti trattati rispetto alla Torrentiniana, come si evidenzia dal veloce confronto fra i due indici, con un accrescimento palese della parte dedicata al Medioevo, ma ancor più di quella riservata alla trattazione dell’età coeva a Vasari. Non meno significativa l’aggiunta – un vero corpus a sé stante – consacrata alle arti degli antichi greci e romani, già menzionata nel frontespizio [Fig. 16] e ricordata nella Lettera agli Eccellenti e carissimi artefici miei:
E perché questa opera venga del tutto perfetta né s’abbia a cercare fuora cosa alcuna, ci ho aggiunto gran parte delle opere de’ più celebrati artefici antichi, così greci come d’altre nazioni, la memoria de’ quali da Plinio e da altri scrittori è stata fino a’ tempi nostri conservata, che senza la penna loro sarebbono, come molte altre, sepolte in sempiterna oblivione (Vasari/BB, I, p. 176).
Il compito qui tratteggiato dal pittore aretino venne affidato alla Lettera di Giovambattista Adriani a Giorgio Vasari, in cui lo storico fiorentino, che Vasari raffigurò accanto a sé, e insieme con don Vincenzio Borghini, in uno dei riquadri del soffitto del Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio (1563-1565) [Fig. 17], passava in rassegna, con una sapiente rimodulazione, le notizie tratte dalla Naturalis Historia. Laddove Plinio distribuisce la trattazione artistica nei libri XXXIV-XXXVI, dedicati, come sappiamo, rispettivamente ai metalli, alle terre e ai materiali lapidei, e quindi alla scultura fusoria, alla pittura e alla lavorazione del marmo, Adriani organizza il proprio scritto in maniera ben diversa, distaccandosi da qualsiasi succube adesione al modello antico (ma aveva ben presenti anche fonti greche, da Strabone a Plutarco, da Pausania a Luciano, nonché altre latine, in primis il Cicerone delle Verrine e del De inventione, ma pure Vitruvio e Valerio Massimo). Apre, infatti, la sua analisi sulle origini dell’arte considerata più antica, ossia la pittura, di cui rimarca l’alta considerazione goduta presso i Greci, tanto da essere praticata solo da uomini liberi (Vasari/BB, I, p.189); e ciò andrebbe sottolineato con attenzione, in un’epoca in cui prendeva sempre più piede la pratica del dilettantismo artistico, ed in particolare pittorico, sancito dal trattato redatto, non casualmente, da Alessandro Allori, un altro dei giovani della vasta bottega del Vasari.
Attraverso il catalogo dei pittori greci (Vasari/BB, I, pp. 189-202), fra cui sono menzionate pure alcune donne (p. 202), si passa a quelli romani (Vasari/BB, I, pp. 202-204). Dopo di che, lo storico fiorentino prende in considerazione la «plastice» (Vasari/BB, I, pp. 204-206), ossia l’arte di modellare con la terra, per poi esaminare le sculture in bronzo e in altri metalli. Ampio spazio è dedicato ai grandi nomi dell’arte fusoria, da Policleto a Lisippo, senza dimenticare ovviamente Fidia e Prassitele (Vasari/BB, I, pp. 206-216). I nomi di tali scultori ricompaiono subito dopo, quando Adriani affronta la nascita e la diffusione della scultura in pietra (Vasari/BB, I, pp. 216- 224), per fermare la propria attenzione sulle grandi statue colossali ed istituire un confronto fra il mondo greco e quello romano, fra i tipi figurativi delle due grandi culture antiche (Vasari/BB, I, pp. 224-226). Le conclusioni (Vasari/BB, I, p. 227) fanno seguito, però, ad un brevissimo excursus sull’oreficeria, ossia sull’arte del vasellame più minuto e raffinato (Vasari/BB, I, pp. 226-227), che si ricollega alla scultura di opere miniaturizzate in marmo (Vasari/BB, I, p. 223), la quale, a sua volta, introduce per converso la già menzionata scultura monumentale lapidea.
Il raffinato gioco d’incastri all’interno del testo rimanda, inoltre, alla struttura delle Teoriche: se Vasari dà inizio alla sua scrittura partendo dall’architettura, per poi affrontare la scultura ed infine la pittura, e come pittore è a quest’arte che dà l’ultima parola, Adriani sembra voler armonizzare l’insieme e chiudere il cerchio della narrazione con un percorso che, alla stregua del modello pliniano, non solo esclude l’arte considerata più quotidiana e utilitaristica, ma che punta tutto sulla grande scultura in marmo monumentale, sia sacra che profana, modello ultimo, guarda caso, per le celebrazioni coeve del principato mediceo. Il testo di Adriani risponde così pienamente a quell’ampio spettro di indagine cui si era votato Vasari nel portare a termine la revisione delle Vite e che era stato uno dei categorici desiderata espressi da don Vincenzio Borghini (1515-1580) nella lettera indirizzata all’artista l’11 agosto 1564:
[…] vi ricordo che mettiate a ordine le cose de’ vivi, massime de’ principali, acciò questa opera sia finita et perfetta da ogni parte, et che sia una HISTORIA universale di tutte le pitture et sculture di Italia etc., et che questo è il fine dello scriver vostro (Frey, II, p. 98)
Borghini, monaco benedettino cassinese e vero deus ex machina del mondo culturale e artistico fiorentino durante il regno di Cosimo I, ebbe un ruolo importante anche nella revisione delle Vite, come testimoniano le numerose missive scambiate con Vasari. Molto interessante quanto leggiamo nella lettera del 14 agosto 1564:
Hora vi bisognerà rigare più diritto, che io ho studiato Plinio et la letione del Varchi et quelle belle lettere del Tasso sopra la pittura, tal che io ci son mezzo dottorato et saprò vedere meglio et giudicare più minutamente le virtù et difetti de l’arte, sì che voi non harete a far più con ciechi: però state in cervello. Ma fuor di baie, io ho letto ben tanto et tanto discorso sopra questa arte, che forse harò trovato qualcosa da non vi dispiacere; et quando io non vo’ dormire, io fo scrivere a ser Marco, che ò meco, et già sono a più di 130 faccie d’un libro in quarto, sì che mettetevi a ordine d’haver che leggere et che masticare (Frey, II, p. 101)
Come ha dimostrato Paola Barocchi, il «libro in quarto di 130 faccie» altro non è che la cosiddetta Selva di notizie, oggi conservata nella Biblioteca del Kunsthistorisches Institut di Firenze, una raccolta di appunti borghiniani sulle arti, dall’Antichità all’età presente (Barocchi 1970). Il valore normativo di testo latino permette di comprendere le amplificazioni dell’edizione giuntina delle Vite: si tratta di una storia delle arti, che si occupa delle tecniche e dei materiali, dei prodotti artistici prima ancora che degli artefici, dove il giudizio storico deve avere la meglio, o per dir più chiaramente, sostanziare quello estetico. Ne è chiarissima riprova la grande attenzione riservata nell’edizione del 1568 all’abilità di Andrea del Verrocchio (m. 1488) nell’imitare in forme scultoree le fattezze dei personaggi da lui ritratti:
Si dilettò assai Andrea di formare di gesso da far presa, cioè di quello che si fa d’una pietra dolce, la quale si cava in quel di Volterra e di Siena et in altri molti luoghi d’Italia. La quale pietra, cotta al fuoco e poi pesta e con l’acqua tiepida impastata, diviene tenera di sorte che se ne fa quello che altri vuole, e dopo rassoda insieme et indurisce in modo che vi si può dentro gettar figure intere. Andrea dunque usò di formare con forme così fatte le cose naturali per poterle con più commodità tenere inanzi e imitarle, cioè mani, piedi, ginocchia, gambe, braccia e torsi (Vasari/BB, III, p. 543).
Le parole ora citate altro non sono che una specie di introduzione a quanto segue, che ha le forme di una riflessione più generale e per noi ancora più interessante:
Dopo si cominciò al tempo suo a formare le teste di coloro che morivano, con poca spesa; onde si vede in ogni casa di Firenze sopra i camini, usci, finestre e cornicioni, infiniti di detti ritratti, tanto ben fatti e naturali che paiono vivi. E da detto tempo in qua si è seguitato e seguita il detto uso, che a noi è stato di gran commodità per avere i ritratti di molti che si sono posti nelle storie del palazzo del duca Cosimo. E di questo si deve certo aver grandissimo obligo alla virtù d’Andrea, che fu de’ primi che cominciasse a metterlo in uso (Vasari/BB, III, pp. 543-544).
Il brano che abbiamo fin qui citato, presente solo nella redazione giuntina delle Vite di Vasari, apparsa a Firenze nel 1568, è straordinariamente importante, perché, sulla scorta di Plinio il Vecchio e del suo lungo excursus sulla plastice, ossia la scultura in terracotta, viene tracciata con sicurezza la storia della tecnica in cui Verrocchio eccelleva, ma soprattutto per le evidenti finalità encomiastiche con cui tale ricostruzione ex post è delineata.
La rilevanza data alla tradizione storica locale, posta sotto l’egida della dinastia medicea, trovava una perfetta rispondenza nella conservazione e/o ricostruzione delle “imagines” dei “maiores”. Anche nei Ragionamenti (pubblicati postumi nel 1588 dal nipote) Vasari non mancò di insistere su questo concetto, sottolineando l’apprezzamento del principe Francesco nei confronti dei ritratti di mano di Andrea del Verrocchio perché «via molto utile a conservar nelle case la memoria di chi l’esalta e le fa nominare» (Giornata seconda, Ragionamento primo). È difficile, avendo sotto gli occhi simili occorrenze vasariane, non pensare a notissimi passi di Plinio presenti nel XXXV libro. Cominceremo proprio con l’esordio del libro in questione (XXXV, 2), laddove lo scrittore romano biasima la passione tipica del suo tempo, una vera moda, per l’uso dei marmi colorati o dei mosaici che hanno soppiantato la pittura. Plinio (XXXV, 4) si lamenta in particolare che sia fortemente decaduta «la pittura di ritratti con la quale venivano tramandate nei secoli figure somiglianti al massimo grado» (Plinio/Conte, V, pp. 295 e 297), decadenza legata all’apprezzamento più del materiale che dell’opera d’arte in sé, o dei valori, etici o storici, ad essa legati. Scriveva, infatti, Plinio (XXXV, 4):
[…] si scambiano le teste alle statue (statuarum capita permutantur), e su quest’uso circolano già da tempo facezie, anche in componimenti poetici. […] sono ritratti del loro denaro (imagines pecuniae), non già delle loro sembianze (Plinio/Conte, V, p. 297).
Se posto in raffronto con il passato il decadimento attuale diventava ancora più evidente, segno di un contrasto stridente anche a livello sociale (XXXV, 6 e 10):
ben diversi erano i ritratti che si potevano vedere negli atrii degli antenati; non statue, opere di artisti stranieri, né in bronzo né in marmo; erano volti modellati in cera che venivano disposti in ordine in singole nicchie per avere immagini che accompagnassero i funerali gentilizi […]. Come io credo, non c’è nessun esempio di fortuna maggiore che quando tutti sempre desiderano sapere di quale aspetto uno fosse in vita (Plinio/Conte, V, pp. 299 e 301).
E, quasi a chiusa del libro (XXXV, 153), parlando della “plastica” o scultura in terracotta Plinio osservava:
Primo di tutti a riprodurre il ritratto umano in gesso derivandolo dalla faccia stessa e, versata della cera nello stampo in gesso, a correggere poi l’immagine fu Lisistrato di Sicione […]. Costui cominciò anche a fare ritratti al naturale; prima di lui cercavano di farli i più belli possibile (Plinio/Conte, V, p. 477).
Le «imagines» degli antenati, preservate in cera o in terracotta o in gesso (con una vicinanza fra i vari materiali che ricorre, significativamente, sia nel testo di Plinio che in quello di Vasari), costituivano un repertorio di memorie, visive e morali, destinate ad avere un forte impatto sui discendenti delle potenti famiglie romane, allo stesso modo che le figure ritratte nella bottega di Verrocchio riuscirono a tramandare le fattezze della stirpe dei Medici e di altri nobili fiorentini.
Per l’artista e biografo aretino, però, la Naturalis Historia era importante non solo come base fondante per l’impalcatura teorica dei suoi scritti, in primis le Vite, ma fungeva pure da imprescindibile stimolo per la sua produzione pittorica, come attestano due delle sue più importanti e complesse realizzazioni, i cicli di affreschi compiuti nelle proprie abitazioni, dapprima ad Arezzo e poi a Firenze. Nella dimora ubicata nella sua città natale, acquistata agli inizi degli anni Quaranta del Cinquecento e a cui lavorò nel corso dello stesso decennio, Vasari raffigurò, nel 1548, fra le altre scene in monocromo (tutte tratte dall’opera di Plinio e concernenti famosi pittori dell’Antichità) che decorano la fascia più bassa della Sala della Virtù (l’ambiente di rappresentanza dell’edificio) anche l’episodio con Timante che dipinge il sacrificio di Ifigenia (XXXV, 73-74). Una scelta certamente non casuale, ma che puntava a celebrare da un lato il nuovo statuto acquisito dall’artista, in grado di rivaleggiare con il rango dei letterati più illustri per l’appena raggiunta considerazione sociale, ma dall’altro, e forse ancora più importante, metteva in evidenza le maggiori capacità della pittura di rappresentare i sentimenti e gli affetti dell’uomo (come la tristezza e il dolore di Agamennone di fronte all’uccisione rituale della figlia), rinfocolando quella aspra contesa che era scoppiata a Firenze fra pittori e scultori giusto l’anno precedente, suscitata dall’inchiesta di Benedetto Varchi (1503-1565) sulla maggioranza delle arti, ossia sulla superiorità dell’una rispetto all’altra. Il filosofo e storico fiorentino non aveva esitato a coinvolgere tutti i principali artisti presenti in città, da Cellini a Bronzino, coinvolgendo pure Michelangelo, residente invece a Roma, e lo stesso Vasari, che avevano risposto inviando ciascuno una propria lettera in merito alla questione.
Non meno significativa la presenza di citazioni dall’opera pliniana nel ciclo di affreschi che decorano il salone della casa fiorentina dell’artista, incentrati sulle figure dei più celebrati pittori del mondo greco, Apelle e Zeusi: quest’ultimo, già protagonista della medesima scena nella dimora aretina, è intento a trarre ispirazione da alcune belle fanciulle discinte per poi poter dipingere una raffigurazione di una dea qui rappresentata come Diana (al posto della Giunone Lacinia menzionata nella Naturalis Historia, XXXV, 64). Se ne evince che Vasari, attraverso la rappresentazione degli episodi tratti da Plinio (è presente, infatti, pure la scena con l’Origine della pittura, XXXV, 15 e 151) puntava ad una celebrazione della propria attività di artista ormai completamente affermato alla corte di Cosimo I de’ Medici e degno di stare alla pari dei grandi precursori del mondo classico ma pure dei più illustri esponenti dell’arte nel corso dei secoli medievali e rinascimentali: nei tondi che compaiono entro la fascia decorativa più in alto figurano, non a caso, Cimabue, Giotto, Masaccio nonché Raffaello, Leonardo e Michelangelo.
Appare allora lampante come la fortuna del testo di Plinio, grazie a Giorgio Vasari, sia stata veicolata tanto nelle sue opere pittoriche quanto nei suoi scritti, ampiamente letti e citati da artisti, letterati e dilettanti delle belle arti delle generazioni successive. Possiamo così comprendere a fondo la pervasiva diffusione proprio degli aneddoti pliniani appena citati, che già oggetto di attenzione da parte di Petrarca nel suo annotare il codice parigino della Naturalis Historia (Bibliothèque Nationale, ms. 6802, cc. 255v e 256r), divennero spunto di dotte riflessioni tanto per il letterato fiorentino Raffaello Borghini (1541 ca.-1588) nel Riposo, pubblicato a Firenze nel 1584 (libro III, pp. 269-270 e 271-272), quanto per il pittore e scrittore milanese Giovanni Paolo Lomazzo (1538-1592), sia nel Trattato dell’arte della pittura, stampato a Milano nel 1584 (libro VI, capp. 3 e 35 e libro VII, cap. 14: Lomazzo/Ciardi, II, pp. 251, 317 e 507) sia nell’Idea del tempio della pittura, apparso nel 1590 (cap. 2: Lomazzo/Ciardi, I, pp. 253). Pure il più significativo esponente del tardo Manierismo, anch’egli pittore affermato e brillante trattatista, il marchigiano Federico Zuccari (1539-1609), attivo presso le più importanti corti d’Europa, nell’Idea de’ pittori, scultori et architetti, edito a Torino nel 1607, non mancava di menzionare fra i suoi scrittori di riferimento Plinio (libro II, cap. 7: Zuccari/Heikamp, p. 255), mentre si servì di un noto passo ciceroniano (De inventione, II, 1-3) per ricordare il celeberrimo aneddoto relativo a Zeusi e ai Crotoniati, per i quali «formò la sua bellissima Venere famosa insino a’ tempi nostri» (libro II, cap. 2: Zuccari/Heikamp, p. 230).
1514. Prima-secunda pars Plyniani indicis editi per Ioannem Camertem … Impressa Viennae Pannoniae, per Hieronymum Victorem, Ioannemque Singrenium artis socios, sumptibus Leonardi, & Lucae Alantseae fratrum.
1524. C. Plinii Secundi Naturalis historiae opus, ab innumeris mendis a d. Iohanne Caesario Iuliacen … vindicatum, inventa primum ab eo, & a nullo quidem antea animadversa, concinna ratione quadam id opus in septem pemptadas siue quinarios dispartiendi: adiectisque in singulos argumentis, & brevisculis simul in margine scholiis, ab eodem illustratum, Coloniae, in aedibus Eucharii Cervicorni.
Fig. 15
G. Vasari, “Delle Vite de’ più eccellenti pittori scultori et architettori scritte da M. Giorgio Vasari pittore et architetto aretino. Primo volume della terza parte […]”, Firenze, Giunti 1568, frontespizio.
Fig. 16
“Giorgio Vasarii, pittore et architetto Aretino” (“Delle Vite […]”, 1568). Cornell University Library, Division of Rare and Manuscript Collections.
§.5. Il Seicento. Per un abbozzo della fortuna del testo pliniano nel XVII secolo: le Vite de’ pittori antichi di Carlo Roberto Dati
(Eliana Carrara)
Tracciato un resoconto necessariamente sommario delle numerose attestazioni della fortuna pliniana nel corso del Cinquecento, è possibile riscontrare una sua persistenza senza soluzione di continuità pure nel secolo successivo, il XVII. Un interessante caso è costituito dall’opera di Carlo Roberto Dati, pubblicata a Firenze nel 1667 con la dedica al re di Francia, Luigi XIV, che aveva concesso una pensione annua al suo autore.
Dati (1619-1676), nato da nobile famiglia, ebbe modo di compiere sia approfonditi studi di carattere letterario, tanto da divenire un perito conoscitore delle lingue classiche, sia di carattere scientifico, con maestri come Galileo Galilei e Evangelista Torricelli. Su indicazione del padre, si dedicò anche alla pratica dell’arte del battiloro, al fine di procurarsi un bagaglio di conoscenze in ambito artigiano e commerciale. Ma fu, ovviamente, la sua preparazione letteraria che gli permise di accedere alle più importanti accademie fiorentine, e in particolare in quella della Crusca, ove – con il nome accademico di Smarrito – lavorò con impegno alla terza edizione del Vocabolario, apparsa poi nel 1691, e dove poté acquisire quella sensibilità per la storia del lessico artistico che trovò impegnato in prima persona in quegli stessi anni una figura del rango di Filippo Baldinucci, che nel 1681 diede alle stampe il Vocabolario toscano dell’arte del disegno.
Clicca qui per maggiori informazioni
Nato in ambito accademico (donde il termine professori per indicare gli artisti), il progetto rimase monco ed apparve solo uno, e per di più ridotto, dei volumi ipotizzati. Infatti, sono solo quattro gli artisti che ebbero una biografia: Zeusi, Parrasio, Apelle e Protogene. Corredate da erudite postille, che mettono in relazione la Naturalis Historia con altre fonti che ricordano i pittori esaminati, le Vite costituiscono, inoltre, un interessante spaccato sul panorama artistico fiorentino di inizio Seicento, poiché istituiscono un confronto con i principali artisti operanti in città quali Giambologna e Cristofano Allori, oltre a rammentare i grandi protagonisti della Maniera Moderna, da Michelangelo a Correggio, da Raffaello a Tiziano, senza dimenticare la gloria tutta patria di Andrea del Sarto.
Approfondimenti
Frey, H.-W. 1923-1940. Der literarische Nachlass Giorgio Vasaris, Mit kritischem Apparate versehen von K. Frey, hrsg. und zu Ende geführt von H.-W. Frey. 3 vols. München (Burg b.M.): Müller (Hopfer). (= Frey, numero volume, numero pagina).
Minto, A. 1953. Le vite dei pittori antichi di Carlo Roberto Dati e gli studi erudito-antiquari nel Seicento. Firenze: Olschki.
Gombrich, E.H. 1966. Norm and Form: Studies in the Art of the Renaissance, 1-10. London and New York: Phaidon ( “La concezione del progresso artistico nel Rinascimento e le relative conseguenze.” In Norma e forma, 3-17. Torino: Einaudi, 1973). Originally published in “The Renaissance Concept of Artistic Progress and its Consequences.” In Actes du XVIIme Congrès international d’histoire de l’art, 291-307 (La Haye: Imprimerie Nationale des Pays-Bas 1955).
Zuccari/Heikamp = Heikamp, D., a cura di 1961. Scritti d’arte di Federico Zuccaro. Firenze: Olschki.
Vasari/BB = Vasari, G. 1966-1987. Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, testo a cura di R. Bettarini, commento secolare a cura di P. Barocchi. 6 vols. Firenze: Sansoni-S.P.E.S.
van de Waal, H. 1967. “The Linea Summae Tenuitatis of Apelles: Pliny’s Phrase and its Interpreters.” Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 12: 5-32.
Lomazzo/Ciardi = Lomazzo, G.P. 1973-1974. Scritti sulle arti, a cura di R.P. Ciardi. 2 vols. Firenze: Marchi e Bertolli.
Becatti, G. 1987. “Plinio e Vasari”. In Kosmos. Studi sul mondo classico, 629-39. Roma: L’Erma di Bretschneider. Originally published in Studi di storia dell’Arte in onore di Valerio Mariani, 173-82 (Napoli: Libreria Scientifica Editrice 1972).
Cheney, L. 1989. “Vasari’s Depiction of Pliny’s Histories.” Explorations in Renaissance Culture 15: 97-120.
Varchi, B. e V. Borghini 1998. Pittura e scultura nel Cinquecento, a cura di P. Barocchi, 85-142. Livorno: Le Sillabe. Originally published in P. Barocchi, “Una ‘Selva di notizie’ di Vincenzo Borghini”, 87-172. In Un augurio a Raffaele Mattioli (Firenze: Sansoni 1970).
Carrara, E. 2002. “Vasari e Borghini sul ritratto: gli appunti pliniani della ‘Selva di notizie’; ms. K 783.16 del Kunsthistorisches Institut di Firenze.” Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 54: 243-91.
Bert, M. 2006. “Pline l’Ancien et l’art de la Renaissance: balises pour une étude de réception entre le Nord et le Sud.” RBA 75: 3-51.
Bert, M. 2007. “Les genres picturaux à la Renaissance et leur modèle antique: émergence d’une classification? Pline, Alberti, Van Mander.” Journal de la Renaissance 5: 129-50.
Bert, M. 2011. “In monochromatis […] quid non exprimit? La réception des arts monochromes dans la critique d’art humaniste à la Renaissance.” In Aux limites de la couleur. Monochromie & polychromie dans les arts (1300-1650), textes réunis et édités par M. Boudon-Machuel, M. Brock et P. Charron, 97-113. Turnhout: Brepols.
Bert, M. 2012. “Figures de l’anecdote plinienne dans la littérature artistique de la Renaissance: le cas du “Dialogo di pittura” (1548) de Paolo Pino.” In La théorie subreptice. Les anecdotes dans la théorie de l’art (XVIe – XVIIIe siècles), textes réunies par E. Hénin, F. Lecercle et L. Wajeman, 53-72. Turnhout: Brepols.
Carrara, E. 2012. “Giovanni Battista Adriani e la stesura della seconda edizione delle Vite: il manoscritto inedito della Lettera a messer Giorgio Vasari.” In “Conosco un ottimo storico dell’arte …”. Per Enrico Castelnuovo. Scritti di allievi e amici pisani, a cura di M.M. Donato e M. Ferretti, 281-9. Pisa: Edizioni della Normale.
Naas, V. 2012. “Anecdotes et théorie de l’art chez Pline l’Ancien.” In La théorie subreptice. Les anecdotes dans la théorie de l’art (XVIe – XVIIIe siècles), textes réunies par E. Hénin, F. Lecercle et L. Wajeman, 39-52. Turnhout: Brepols.
Sisto, P. 2012. “La Naturalis Historia di Plinio nella trattatistica delle imprese e degli emblemi. Parole e immagini.” In La Naturalis Historia di Plinio nella tradizione medievale e umanistica, a cura di V. Maraglino, 303-25. Bari: Cacucci.
Blake McHam, S. 2013. Pliny and the Artistic Culture of the Italian Renaissance. New Have-London: Yale University Press.
Fane-Saunders, P. 2016. Pliny the Elder and the Emergence of Renaissance Architecture. Cambridge: Cambridge University Press.
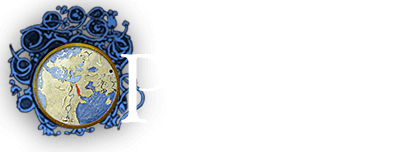
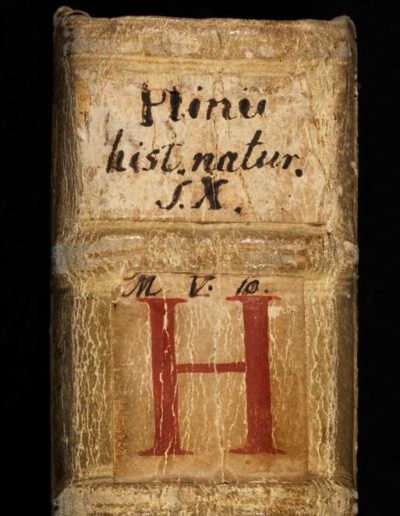
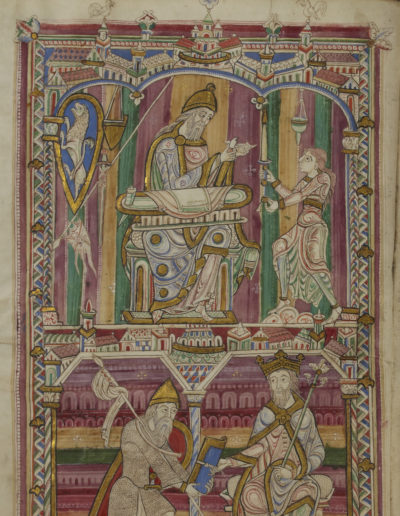
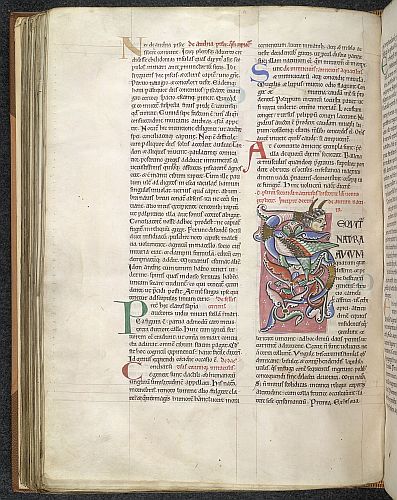
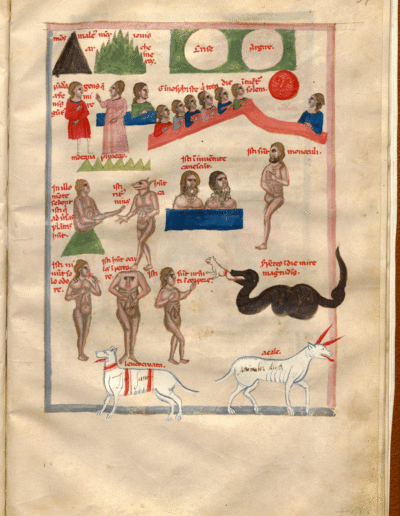
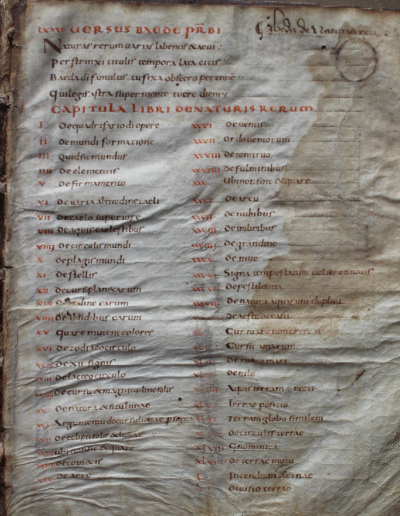
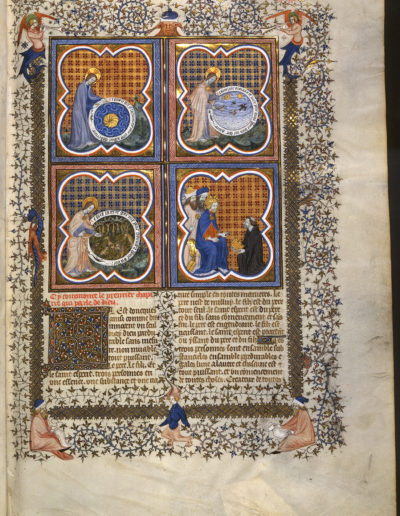
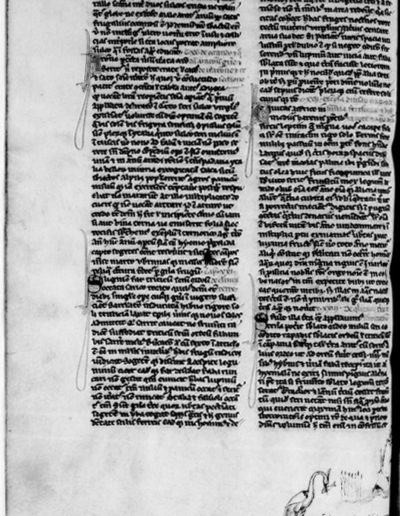
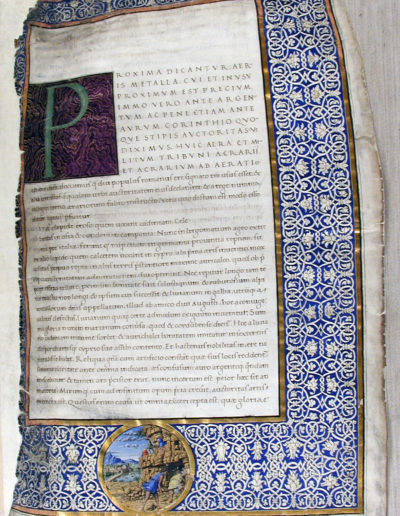
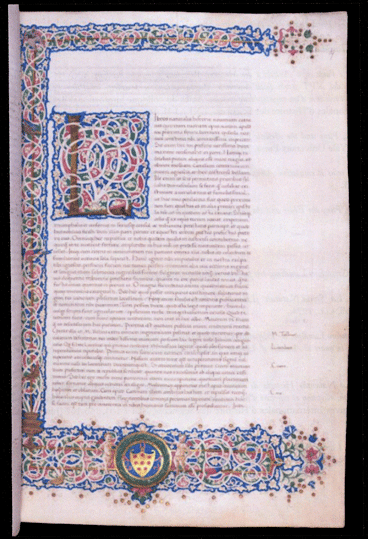
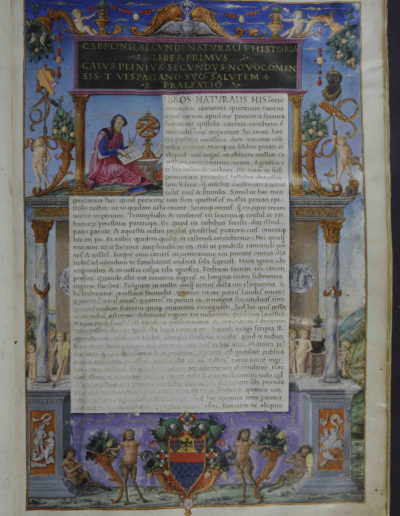

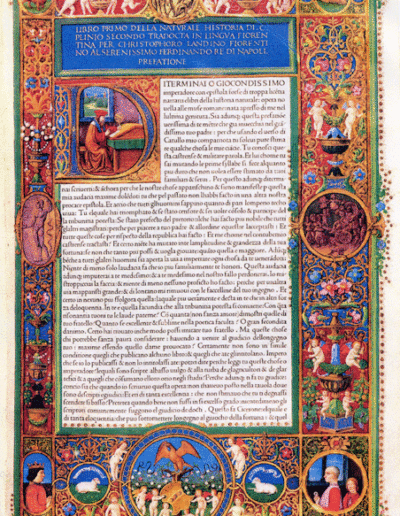
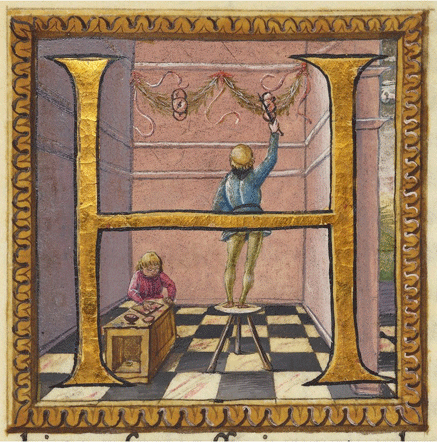
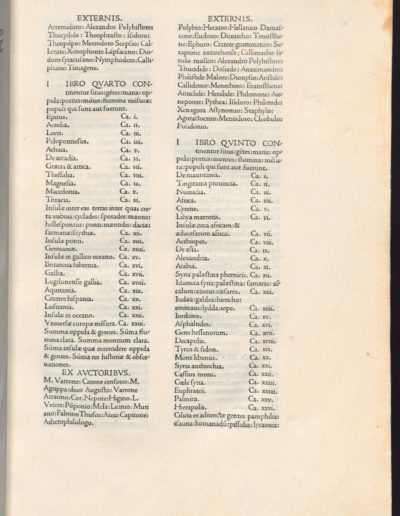
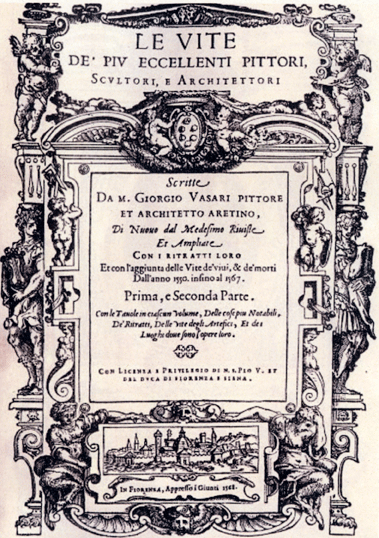
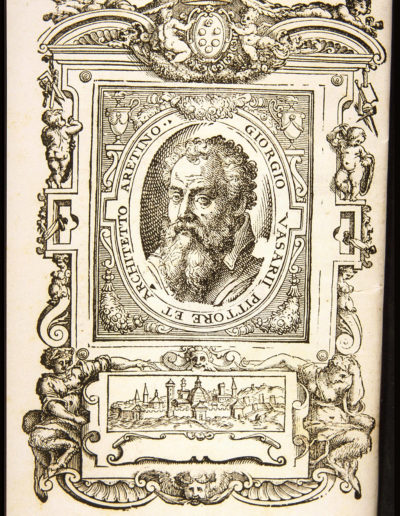

Indice
§.1. L’autore e l’opera
§.2. La trasmissione della NH
§.2.1. Tarda antichità e alto Medioevo
§.2.2. Il Trecento
§.3. Il Quattrocento
§.3.1. Le imprese editoriali
§.3.2. L’antiquaria e la trattatistica d’arte
§.3.3. Il volgarizzamento di C. Landino
§.4. Il Cinquecento
§.5. Il Seicento